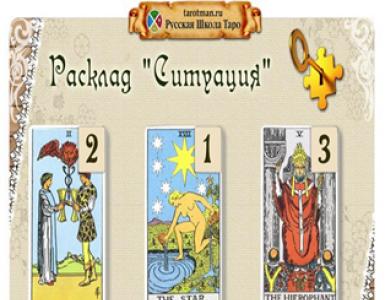Leucemia linfoblastica a cellule T. Cos’è la leucemia linfoblastica? Quali sono i principali sintomi della leucemia linfoblastica
Nella leucemia, le cellule tumorali del midollo osseo entrano nel flusso sanguigno in gran numero, sostituendo le forme mature di globuli bianchi.
Esistono diversi tipi di leucemia. La maggior parte di essi si verifica nei globuli bianchi, che fanno parte del sistema immunitario del corpo. La prognosi e la sopravvivenza nella maggior parte dei casi dipendono dalla definizione accurata della malattia, diagnosi precoce e un trattamento tempestivo ed efficace.
Principali tipi di leucemia
- Leucemia linfoblastica acuta.
- Leucemia mieloide acuta.
- Leucemia linfocitica cronica.
- Leucemia mieloide cronica.
La parola "acuta" significa che la malattia si sviluppa e progredisce abbastanza rapidamente.
Il termine "cronico" indica un lungo decorso della malattia senza alcuna terapia.
Le denominazioni "linfoblastiche" e "linfocitiche" indicano cellule anormali che derivano dai tessuti staminali linfoidi. E “mieloide” indica lo sviluppo di tessuti mutati da una cellula staminale mieloide.
Sopravvivenza alla leucemia
Il tasso di sopravvivenza al cancro indica la percentuale di persone che vivono per un certo periodo. In media, i medici utilizzano una prognosi di 5 e 10 anni, ma ciò non significa che il paziente non vivrà più a lungo di queste cifre.
Inoltre, per ogni persona, la prognosi è puramente indicatori individuali, che possono variare a seconda del decorso della malattia e della risposta del corpo alla terapia. In qualsiasi momento i dati possono cambiare, il che è influenzato dal “comportamento” del tumore e dalla sua tendenza a progredire.
La sopravvivenza include persone a diversi stadi della malattia:
- persone che hanno raggiunto risultati remissione completa, e la malattia non si ripresenta;
- persone che hanno avuto una recidiva preliminare del tumore, ma sono attualmente in remissione;
- persone che hanno la leucemia attiva.
Leucemia linfoblastica acuta: prognosi della malattia
I risultati del trattamento dipendono da diversi fattori:
- Tipo di leucemia e stadio alla diagnosi.
- Livello di risposta al trattamento chemioterapico.
Di tutti gli adulti, fino a 4 persone su 10 (40%) vivranno almeno 5 anni. Alcuni di questi pazienti guariranno in modo permanente, ma in altri casi esiste il rischio che la malattia ritorni. Questa è chiamata “leucemia secondaria”. La leucemia secondaria si sviluppa dopo la chemioterapia da un precedente tumore, quando le cellule del midollo osseo sono danneggiate. Tuttavia, anche dopo una ricaduta, rimane una certa percentuale di casi in cui si verifica una seconda remissione.
Tassi di sopravvivenza per le persone con leucemia mieloide acuta
Nel complesso, la sopravvivenza a 5 anni è di circa il 25% e varia dal 22% negli uomini al 26% nelle donne.
L'oncologia mostra che ci sono alcune condizioni che influenzano la prognosi positiva del trattamento:
- le cellule leucemiche si trovano tra i cromosomi 8 e 21 o tra i cromosomi 15 e 17;
- le cellule leucemiche hanno un'inversione del cromosoma 16;
- le cellule non sono caratterizzate da cambiamenti in geni specifici;
- età inferiore a 60 anni;
La prognosi può essere peggiore nelle seguenti condizioni:
- nelle cellule leucemiche manca una parte dei cromosomi 5 o 7;
- le cellule leucemiche presentano cambiamenti complessi che interessano molti cromosomi;
- i cambiamenti cellulari si osservano a livello genetico;
- età avanzata (da 60 anni);
- leucociti nel sangue al momento della diagnosi;
- la leucemia non risponde al trattamento iniziale;
- si osserva un avvelenamento del sangue attivo.
Leucemia linfocitica cronica: prognosi per i pazienti affetti da cancro
Una malattia maligna del sangue e del midollo osseo, in cui vengono prodotti troppi globuli bianchi, non sempre fornisce dati prognostici rassicuranti.
Le possibilità di recupero dipendono da:
- livello di cambiamento nella struttura del DNA e nel suo tipo;
- la prevalenza di cellule maligne nel midollo osseo;
- fasi della malattia;
- trattamento primario o conseguente recidiva;
- progressione.
Leucemia mieloide cronica: prognosi
La malattia si verifica nelle cellule ematopoietiche pluripotenti, influenzando la formazione del tessuto leucemico a tutti i livelli della composizione molecolare del sangue.
La prognosi di questo tipo di leucemia è cambiata significativamente negli ultimi anni a causa dei nuovi metodi terapeutici, in particolare del trapianto di midollo osseo e di cellule staminali. Pertanto, il tasso di sopravvivenza a 5 anni diventa del 40-80% e il tasso di sopravvivenza a 10 anni diventa del 30-60%.
La sopravvivenza con la terapia con idrossiurea è di 4-5 anni. Quando viene utilizzato l'interferone, da solo o in combinazione con la citarabina, i numeri quasi raddoppiano. Anche la somministrazione di imatinib ha avuto un effetto positivo sulla prognosi del paziente (85% rispetto al 37% con il solo interferone).
Statistiche riassuntive di sopravvivenza per la leucemia
Le statistiche di sopravvivenza a uno, cinque e dieci anni diventano:
- Il 71% degli uomini con trattamenti combinati vive almeno un anno. Questo tasso scende al 54% che sopravvive a cinque anni. Per le donne, la leucemia è caratterizzata da dati prognostici diversi. Le cifre sono leggermente inferiori: si prevede che il 66% delle donne sopravviva per un anno e il 49% dei pazienti dovrebbe sopravvivere per cinque anni.
- Per la leucemia, il tasso di sopravvivenza previsto diminuisce gradualmente e dopo 10 anni porta ai seguenti dati: il 48% degli uomini e il 44% delle donne trarranno beneficio dal trattamento.
La previsione della sopravvivenza in base all’età diventa:
- La positività è più elevata tra gli uomini e le donne più giovani e diminuisce con l’età.
- Il tasso di sopravvivenza a cinque anni negli uomini varia dal 67% all’80-99% di età al 23% all’80-99% di età. Nella donna il cancro, tenendo conto delle condizioni prognostiche, ha le stesse indicazioni.
- La sopravvivenza netta a 10 anni è recentemente migliorata del 7% rispetto agli anni ’90. In generale, 4 persone su 10 nel 2014 sono guarite completamente dalla malattia.
È importante sapere:
commenti 4
Chi ha scritto l'articolo? La leucemia è inizialmente acuta o cronica! L'acuto non diventa cronico, queste non sono malattie infettive
La diagnosi di CLL è stata fatta nel 2009. Nel 2013 ha completato 6 cicli di chemioterapia presso l'Ospedale Regionale di Vologda. La chemioterapia è stata iniziata quando il livello dei leucociti era di 110 unità. Dopo la chemioterapia, MabThera è stato infuso tramite contagocce ogni 3 mesi, 8 contagocce in totale. quelli. 2 anni. Ora i test rientrano nei limiti accettabili. Dicono che c'è un periodo di recessione, sono sotto controllo medico da 8 anni.
Com'è la qualità della vita?
Com'è la qualità della vita? Cosa aspettarsi??
Aggiungi un commento Cancella risposta
Categorie:
Le informazioni sul sito sono presentate solo a scopo informativo! Non è consigliabile utilizzare i metodi e le ricette descritti per il trattamento del cancro da soli e senza consultare un medico!
Leucemia linfoblastica acuta
Una delle malattie più comuni di origine oncologica tra i bambini è la leucemia linfoblastica acuta.
La sua quota rappresenta l'80% del numero di casi di malattie del sistema ematopoietico. Secondo le statistiche, i ragazzi sono colpiti più spesso delle ragazze. Il picco della malattia si verifica tra uno e sei anni.
Negli adulti, la malattia è molto meno comune. Cos’è la leucemia linfoblastica acuta? Si tratta di un tumore del sistema emopoietico, caratterizzato dalla proliferazione incontrollata di cellule linfoidi immature.
Nei bambini, la LLA si sviluppa principalmente, mentre negli adulti è una complicanza clinica leucemia linfocitica di carattere cronico. I sintomi della leucemia linfocitica acuta sono simili ad altri tipi di leucemia. La differenza è il danno alla membrana del cervello e del midollo spinale. Trattamento di acuto leucemia linfoblastica effettuato da specialisti nel campo dell’ematologia e dell’oncologia.
Ragioni per lo sviluppo della malattia
La causa principale della leucemia linfoblastica acuta è la formazione di un clone tumorale (un gruppo di cellule maligne che hanno la capacità di riprodursi in modo incontrollabile).
Un clone nasce a causa di aberrazioni cromosomiche:
- traslocazioni - scambio di sezioni tra due cromosomi;
- delezione – rappresenta la perdita di una sezione di un cromosoma;
- inversione – inversione di una sezione cromosomica;
- amplificazione – la formazione di copie di sezioni cromosomiche.
Si ritiene che la malattia genetica che causa la LAL si manifesti nell'utero. Ma per completare la formazione di un clone del cancro sono necessarie ulteriori circostanze di origine esterna.
Fattori di rischio
Uno dei fattori di rischio per lo sviluppo di questa patologia è considerato l'esposizione alle radiazioni: vita in una zona con alti livelli di radiazioni ionizzanti, radioterapia nel trattamento di altri tumori, numerosi esami radiografici (compresi quelli intrauterini).
Il livello di connessione, l'evidenza della presenza di una relazione tra vari fattori e lo sviluppo della leucemia linfoblastica acuta differiscono.
La connessione tra radioterapia e leucemia è oggi considerata provata. Il rischio di sviluppare LLA dopo l'esposizione alle radiazioni è di circa dieci casi su cento. Ottanta persone sviluppano la malattia nei successivi dieci anni dopo aver completato la radioterapia.
La relazione tra gli esami radiografici e l'AOL rimane speculativa. Non esiste una conferma statistica affidabile della teoria.
Gli esperti parlano di una possibile connessione tra leucemia linfoblastica acuta e malattie infettive. Il virus ALL non è stato ancora identificato.
Ci sono due teorie:
- La leucemia linfoblastica acuta è formata da un virus ancora sconosciuto, ma la malattia stessa si sviluppa solo se esiste una predisposizione.
- La causa di TUTTI può essere varia virus diversi, il rischio di leucemia nei bambini aumenta in caso di contatto insufficiente con microrganismi patogeni durante la prima infanzia.
Queste due teorie non sono state provate, poiché informazioni attendibili sulla relazione tra leucemia e malattie virali sono state ottenute solo per un gruppo di leucemie in pazienti adulti che vivono nei paesi asiatici.
La probabilità di sviluppare LLA può aumentare se la madre durante la gravidanza entra in contatto con determinate sostanze di origine tossica, nonché con anomalie genetiche (sindrome di Down, anemia di Fanconi, sindrome di Shwachman, sindrome di Klinefelter, neurofibromatosi) e con una predisposizione genetica. Alcuni scienziati notano l'influenza del fumo.
Sintomi
Lo sviluppo della leucemia linfoblastica acuta avviene rapidamente. Al momento della diagnosi, la massa totale dei linfoblasti nel corpo umano corrisponde a circa il 3% del peso corporeo del paziente. Ciò è dovuto alla proliferazione delle cellule tumorali negli ultimi due o tre mesi. Il numero di cellule può raddoppiare nel corso di una settimana. Esistono diverse sindromi caratteristiche della leucemia linfoblastica acuta:
Intossicante. I sintomi della sindrome comprendono ⏤ debolezza, affaticamento, febbre e perdita di peso. La temperatura elevata può essere dovuta sia alla malattia di base che a complicazioni infettive.
- Sindrome iperplastica. Questa sindrome può manifestarsi con linfonodi ingrossati, ingrossamento del fegato e della milza (il risultato dell'infiltrazione leucemica del parenchima dell'organo). Con gli organi ingrossati può verificarsi dolore nella zona addominale. Con l'infiltrazione del periostio, dei tessuti delle capsule articolari e un aumento del volume del midollo osseo, può verificarsi dolore osteoarticolare.
- Sindrome anemica. In presenza di tale sindrome si verificano i seguenti sintomi: vertigini, debolezza, pallore e aumento della frequenza cardiaca.
- Sindrome emorragica. I segni di questa sindrome possono includere petecchie ed ecchimosi che si formano sulla pelle e sulle mucose. Inoltre, estese emorragie sottocutanee con lividi che si verificano facilmente possono indicare la presenza di sindrome emorragica. Vi è un aumento del sanguinamento da graffi e cancro, sanguinamento dal naso e dalle gengive. Alcuni pazienti manifestano sanguinamento gastrointestinale, accompagnato da feci catramose e vomito con sangue.
- Sindrome infettiva. I disturbi immunitari in TUTTI possono manifestarsi come infezione persistente di ferite e graffi. Si sviluppano diverse infezioni batteriche, virali e fungine. Con i linfonodi ingrossati del mediastino, si osserva una respirazione compromessa a causa di una diminuzione del volume polmonare.
Se il sistema nervoso centrale è coinvolto nel processo patologico, vengono rilevati sintomi meningei positivi, nonché segni di aumento della pressione intracranica (gonfiore dei dischi ottici, nausea e vomito, accompagnati da mal di testa). In alcuni casi, il danno al sistema nervoso centrale nella LLA si verifica senza sintomi visibili e viene determinato solo dopo studi sul liquido cerebrospinale.
Nei pazienti compaiono infiltrati blu-viola sulla pelle e sulle mucose. Nei ragazzi possono comparire infiltrati nei testicoli. In alcuni casi di leucemia linfoblastica acuta si verificano versamento pericardico e compromissione della funzionalità renale.
Tenendo conto delle caratteristiche dei sintomi clinici, si distinguono quattro periodi di sviluppo della LLA:
- Elementare. La durata varia da uno a tre mesi. Predominano i sintomi aspecifici sotto forma di affaticamento, letargia, perdita di appetito e crescente pallore della pelle. Sono possibili dolori addominali, mal di testa e dolori ossei.
- Periodo alto. Appaiono tutte le sindromi elencate.
- Periodo di remissione. Caratterizzato dalla scomparsa di tutti i sintomi.
- Periodo terminale. Le condizioni del paziente peggiorano, spesso provocando la morte.
Diagnostica
La diagnosi di leucemia linfoblastica acuta viene effettuata al momento della registrazione sintomi clinici, risultati dei dati del miogramma e sangue periferico. Nel sangue periferico dei pazienti con LLA vengono rilevati anemia, aumento della VES, trombocitopenia e cambiamenti nel numero dei leucociti. Il numero dei linfoblasti costituisce oltre il venti per cento del numero totale dei leucociti. Il numero di neutrofili è ridotto e il mielogramma rivela la predominanza delle cellule blastiche e viene determinata l'inibizione dei germogli neutrofili, eritroidi e piastrinici.
Il programma di esame per la leucemia linfoblastica acuta prevede i seguenti metodi:
- puntura lombare (per escludere la neuroleucemia);
- Ultrasuoni degli organi addominali (per determinare la condizione organi parenchimali e linfonodi);
- Radiografia del torace (per rilevare ingrossamento linfonodi mediastino);
- Analisi del sangue biochimica (per identificare disturbi delle funzioni renali ed epatiche);
- Analisi differenziale (eseguita per gravi malattie infettive).
Trattamento della leucemia
Gli esperti distinguono due tipi di trattamento per la leucemia linfoblastica acuta:
- Terapia intensiva. Lo stage è composto da due fasi della durata di circa sei mesi. Nella prima fase viene effettuata la polichemioterapia endovenosa per ottenere la remissione. Lo stato di remissione è indicato dalla normalizzazione dell'ematopoiesi, dalla presenza di non più del 5% di blasti nel midollo osseo e dalla loro assenza nel sangue periferico. Nella seconda fase viene effettuato un intervento volto a prolungare la remissione, arrestare o rallentare la proliferazione delle cellule del clone tumorale. I farmaci vengono somministrati per via endovenosa.
- Terapia di mantenimento. La durata della terapia per la leucemia linfoblastica acuta è di circa due anni. Il paziente viene trattato in regime ambulatoriale, gli vengono prescritti farmaci per la somministrazione orale e viene sottoposto a esami regolari per monitorare le condizioni del flusso sanguigno periferico e del midollo osseo.
Il piano di trattamento per la leucemia linfoblastica acuta viene elaborato su base individuale, tenendo conto del livello di rischio di ciascun paziente.
Insieme alla chemioterapia possono essere utilizzati altri metodi: immunoterapia, radioterapia, ecc. Se il trattamento non è sufficientemente efficace e grande rischio sviluppo di recidive, viene eseguito il trapianto di midollo osseo.
Oggi esistono tre metodi di trattamento standard:
- La chemioterapia è un modo per curare il cancro utilizzando potenti farmaci chemioterapici. Questi farmaci possono arrestare e distruggere la crescita delle cellule maligne e impedire loro di staccarsi e di entrare negli organi e nei tessuti. Durante la chemioterapia, i farmaci possono essere assunti per via orale o somministrati per via endovenosa/intramuscolare. A causa del fatto che il medicinale entra nel flusso sanguigno e si diffonde in tutto il corpo, può attaccare tutte le cellule maligne.
La chemioterapia intratecale viene utilizzata durante il trattamento di un adulto affetto da leucemia linfoblastica acuta che tende a diffondersi al midollo spinale. La terapia intratecale viene utilizzata in combinazione con la chemioterapia convenzionale.
- La radioterapia è un trattamento contro il cancro che utilizza speciali raggi X o altri tipi di radiazioni per uccidere le cellule tumorali e prevenirne la crescita. Esistono due tipi di questa terapia: radioterapia esterna e interna.
La terapia esterna prevede la focalizzazione della radiazione con un dispositivo speciale nell'area del tumore. La terapia interna prevede l'utilizzo di farmaci radioattivi, confezionati ermeticamente in capsule, aghi, cateteri e inseriti direttamente nel tumore stesso. La radioterapia a fasci esterni viene utilizzata per trattare la leucemia linfoblastica acuta dell'adulto che tende a diffondersi al midollo spinale.
- La terapia biologica è un tipo di trattamento che utilizza il sistema immunitario del paziente per combattere il cancro. Le sostanze prodotte nell'organismo o sintetizzate nei laboratori vengono utilizzate per stimolare o ripristinare il meccanismo di difesa naturale e combattere le malattie maligne.
Previsione
La prognosi della leucemia linfoblastica acuta si basa sul tempo che il paziente sopravviverà dopo un ciclo di trattamento senza ricadute. Se non si verifica alcuna recidiva entro cinque anni dal completamento del trattamento, il paziente è considerato guarito.
Consulenza legale gratuita:
La leucemia linfoblastica infantile risponde bene al trattamento utilizzando protocolli moderni, il tasso di sopravvivenza a cinque anni è del 90%.
La prognosi può essere influenzata da fattori:
- età del paziente;
- livello di leucociti nel sangue;
- comparsa di ricadute.
Il tasso di sopravvivenza a cinque anni dei bambini di età compresa tra 2 e 6 anni è una volta e mezza più lungo di quello degli altri pazienti. La prognosi dei neonati è spesso sfavorevole. Il tasso di sopravvivenza a cinque anni tra gli anziani è del 55%.
Cos’è la leucemia linfoblastica acuta?
La leucemia linfoblastica acuta è una patologia maligna del sistema ematopoietico, accompagnata da riproduzione incontrollata e un aumento del numero di linfoblasti - cellule linfoidi immature.
Nel midollo osseo si forma un numero eccessivo di linfociti immaturi, che porta allo spostamento delle cellule sane dal tessuto.
La leucemia colpisce quasi tutti gli organi, diffondendosi al sistema nervoso centrale, al nervo ottico, agli organi riproduttivi e ai polmoni. È considerato un tumore maligno sistemico e richiede un trattamento intensivo immediato. La leucemia linfoblastica acuta si sviluppa più spesso nei bambini e negli adolescenti che negli adulti.
- Tutte le informazioni sul sito sono solo a scopo informativo e NON sono una guida all'azione!
- Solo un MEDICO può darti una DIAGNOSI ACCURATA!
- Vi chiediamo gentilmente di NON automedicare, ma di fissare un appuntamento con uno specialista!
- Salute a te e ai tuoi cari! Non arrenderti
Il picco di incidenza si verifica tra uno e cinque anni di età. L’incidenza è più bassa tra le ragazze che tra i ragazzi.
Lo sviluppo della malattia nei bambini è causato dalla degenerazione maligna dei linfociti, che comporta la cessazione dello sviluppo di nuove cellule. Il processo di arresto dello sviluppo cellulare può verificarsi in qualsiasi fase della formazione cellulare, di conseguenza, TUTTI possono manifestarsi in varie forme che differiscono nel loro decorso e richiedono diversi approcci terapeutici.
La leucemia linfoblastica B è più comune della forma T e si verifica più spesso nei bambini di tre anni di età, quando il corpo del bambino produce attivamente cellule B nel midollo osseo. La leucemia linfoblastica a cellule T si sviluppa più spesso durante l'adolescenza.
La leucemia linfoblastica acuta si manifesta meno frequentemente negli adulti, soprattutto in età avanzata (dopo i 60 anni). La malattia negli adulti è spesso accompagnata da danni al sistema nervoso ed è meno curabile.
La leucemia linfoblastica acuta nelle donne in gravidanza non è comune; si sviluppa in donne che hanno avuto la leucemia durante l'infanzia e che con il trattamento sono riuscite a ottenere la remissione. Tuttavia, la gravidanza non influisce sul decorso della malattia. Se una donna incinta ha la leucemia, aumenta il rischio di aborto spontaneo, nascita prematura. L'esito della gravidanza è determinato dall'efficacia della terapia. L'infiltrazione leucemica dei tessuti placentari e fetali è rara.
Video: leucemia linfoblastica acuta in dettaglio
Cause
Le cause della leucemia linfoblastica acuta non sono state completamente identificate. Si ritiene che l'insorgenza della malattia possa essere influenzata sia da fattori ereditari che esterni.
I fattori di rischio includono:
- malattie infettive subite nell'infanzia, in cui si è verificata una risposta anomala del sistema immunitario alla presenza di un agente infettivo;
- trattamento di una particolare malattia mediante radioterapia, esposizione a radiazioni ionizzanti;
- l'impatto dei mutageni biologici su corpo femminile durante la gravidanza;
- predisposizione genetica;
- anomalie cromosomiche e patologie genetiche.
Sintomi della leucemia linfoblastica acuta
Ci sono 5 fasi nello sviluppo della patologia:
- periodo pre-leucemico;
- esacerbazione della malattia;
- periodo di remissione;
- ricaduta;
- periodo terminale.
La presenza degli ultimi due stadi è determinata dal successo del trattamento: se la terapia è efficace essi sono assenti. Con la resistenza primaria, gli stadi di remissione si alternano alle ricadute.
Periodo pre-leucemico
È caratterizzato dall'assenza di manifestazioni cliniche evidenti della malattia e dall'impossibilità di diagnosi.
Periodo acuto
Inizia rapidamente, caratterizzato da varie manifestazioni cliniche con proliferazione tessuto maligno E compromissione funzionale emopoiesi.
C'è un aumento dei linfonodi, delle dimensioni organi interni, degenerazione blastica del midollo osseo. Negli adulti, nella fase di esacerbazione della malattia, si notano intossicazione, sindrome emorragica e iperplastica e anoressia.
Sindrome da intossicazione accompagnato da debolezza generale, febbre e perdita di peso. La sindrome iperplastica è accompagnata da linfonodi ingrossati (soprattutto nella regione inguinale e ascellare, nella zona del collo), dolore addominale con ingrossamento della milza e del fegato, dolore alle ossa e alle articolazioni, edema, fratture patologiche e aumento del midollo osseo volume.
La sindrome anemica è caratterizzata da pelle pallida, debolezza e tachicardia. La sindrome emorragica è espressa da emorragie piccole o significative, sanguinamento nasale, renale e intestinale.
Ricaduta
La recidiva può manifestarsi con i seguenti disturbi degli organi interni:
- formazione sulla superficie della pelle e dentro tessuto sottocutaneo leucemidi;
- emorragia oculare, papilledema;
- sindrome da insufficienza respiratoria della vena cava superiore, emorragia nel tessuto polmonare, sua infiltrazione;
- reni ingrossati senza altre manifestazioni cliniche;
- aumento indolore delle dimensioni dei testicoli nei ragazzi.
Tali sintomi compaiono fasi iniziali le malattie indicano una prognosi infausta.
Diagnostica
Per confermare/escludere la diagnosi si effettuano i seguenti studi:
- analisi del sangue generale;
- esame della puntura del midollo osseo;
- esame della rachicentesi;
- esame ecografico e radiografia degli organi addominali;
- chimica del sangue.
La diagnosi differenziale consente quasi sempre di identificare la malattia con un elevato grado di certezza. Quando si effettua una diagnosi, è necessario prima escludere altre malattie accompagnate da danni al midollo osseo: anemia aplastica, mielofibrosi, Mononucleosi infettiva e altri.
In questo articolo puoi conoscere in dettaglio il trattamento della leucemia in Russia.
Metodi di trattamento
Il trattamento della leucemia linfoblastica acuta viene effettuato in più fasi:
- La terapia intensiva è necessaria per ottenere la remissione della malattia, rimuovere tutte le cellule maligne nel corpo e ripristinare la normale funzione del midollo osseo. La chemioterapia multicomponente viene effettuata con citostatici - medicinali, distruggendo le cellule leucemiche. Alcuni pazienti vengono inoltre sottoposti a radiazioni al cervello. Contemporaneamente all'uso della chemioterapia, viene effettuata una terapia di accompagnamento volta a combattere le malattie infettive, eliminando la sindrome da intossicazione e gli effetti collaterali della chemioterapia. Nella trombocitopenia e nell'anemia gravi vengono eseguite trasfusioni di sostituti del sangue;
- la fase di consolidamento della remissione (consolidamento multi-agente) consiste nella somministrazione di farmaci chemioterapici per eliminare gli effetti patologici residui. Il corso di rafforzamento è progettato per diversi mesi;
- La terapia di mantenimento con antimetaboliti prevede l'assunzione di farmaci in compresse per diversi anni.
Il trapianto di midollo osseo è possibile per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta.
Il trapianto viene effettuato dopo aver raggiunto la fase di remissione. Allo stesso tempo, è importante prevenire l’aggiunta di processi infettivi, poiché durante il trapianto il sistema immunitario viene notevolmente indebolito. Esistono vari programmi di trattamento per TUTTI. La scelta di un particolare programma si basa sulla divisione dei pazienti in gruppi in base all'intensità della terapia utilizzata, alla velocità di risposta alla terapia e alla prognosi attesa.
Per i pazienti che hanno ottenuto la remissione con la chemioterapia moderata, non deve essere utilizzata una terapia severa e tossica. Qualsiasi protocollo di trattamento per la leucemia linfoblastica acuta si basa sui principi della chemioterapia intensiva mirata a distruggere le cellule leucemiche.
I sintomi della leucemia cronica negli adulti sono descritti qui.
Questo articolo ti spiegherà perché i bambini si ammalano di leucemia.
Prognosi (sopravvivenza)
La leucemia linfoblastica acuta nei bambini è molto più curabile che negli adulti.
Pertanto, durante l'infanzia, nel 70% dei casi si ottiene una remissione di cinque anni. Negli adulti, questa cifra è solo del 20%.
Negli adulti, i processi di ricaduta sono più comuni. Il trattamento ripetuto dopo la recidiva ha buoni risultati in media nel 35% dei casi. Allo stesso tempo, la leucemia t-linfoblastica è caratterizzata dalla prognosi peggiore; raramente è possibile curare questa forma.
È impossibile prevedere in anticipo il decorso della malattia nella leucemia linfoblastica acuta.
La malattia può finire in modo del tutto imprevedibile, sia con un decorso favorevole che con forme complesse.
- Evgeniy su Esame del sangue per le cellule tumorali
- Marina sul trattamento del sarcoma in Israele
- Nadezhda su Leucemia acuta
- Galina sul trattamento del cancro ai polmoni con rimedi popolari
- chirurgo maxillo-facciale e plastico per la registrazione dell'Osteoma del seno frontale
Le informazioni sul sito sono fornite esclusivamente per scopi informativi divulgativi, non pretendono di essere riferimenti o accuratezza medica e non costituiscono una guida all'azione.
Non automedicare. Consulta il tuo medico.
Quanto tempo vivono le persone affette da leucemia linfoblastica acuta?
Le malattie del cancro sono sempre state considerate fatali, motivo per cui i pazienti affetti da questa malattia hanno all'incirca le stesse domande, ad esempio, leucemia linfoblastica acuta, tasso di sopravvivenza per questa malattia. Naturalmente, tali malattie spesso portano alla morte, ma esiste una possibilità di guarigione. Facciamo conoscenza con questa pericolosa malattia e scopriamo le statistiche e la prognosi dei medici.
Un po 'sulla malattia stessa
Queste cellule sottosviluppate si moltiplicano rapidamente nel corpo e riempiono i vasi sanguigni. Di conseguenza, le cellule del sangue normali smettono di funzionare. Inoltre, i linfoblasti si accumulano in alcuni organi del nostro corpo. Nel tempo, possono essere trovati in grandi quantità nel fegato, nei linfonodi, nella milza, nel sistema nervoso centrale, ecc. Tutto ciò porta all'intossicazione e alla diminuzione delle difese immunitarie del corpo.
I medici hanno identificato diverse ragioni per questo malattia pericolosa. Conoscerli può aiutare a fare una prognosi corretta per lo sviluppo della malattia.
Gli esperti attribuiscono le ragioni principali a:
- predisposizione ereditaria. Se un parente ha già sofferto di questa malattia, anche il bambino ne soffre Grande opportunità contrarre questo tipo di cancro;
- per alcune malattie genetiche. Tali malattie includono la sindrome di Down, la neurofibromatosi, l'immunodeficienza primaria e una serie di altre;
- Gli adulti possono sviluppare leucemia linfoblastica acuta dopo il trattamento con radioterapia o dopo l'uso di farmaci citotossici.
La prognosi per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) è molto difficile. Il fatto è che questa malattia non viene praticamente diagnosticata nelle fasi iniziali.
Per molto tempo potrebbe non apparire alcun segno. Inoltre, la malattia progredisce piuttosto lentamente rispetto ad altre leucemie.
Sintomi della malattia
Se all'inizio non compaiono sintomi specifici, nelle fasi successive possono comparire uno o più segni.
- Debolezza in tutto il corpo, perdita di appetito, perdita di peso, febbre periodica. Tutti questi segni si riferiscono alla sindrome da intossicazione.
- La sindrome anemica provoca battito cardiaco accelerato, aumento della fatica, pallore della pelle. Allo stesso tempo, il livello di anemia non scende al di sotto del moderato.
- La sindrome emorragica si manifesta sotto forma di piccole emorragie sulla pelle e sulle mucose. Possono comparire lividi e le gengive possono sanguinare, ma il sanguinamento massiccio è estremamente raro.
- La sindrome iperplastica provoca l'ingrossamento dei linfonodi zone inguinali, sul collo e sotto le ascelle. Inoltre, quasi la metà dei pazienti presenta fegato e milza ingrossati.
- Appare anche la sindrome da immunodeficienza. I pazienti possono ammalarsi facilmente, anche a causa di un’infezione lieve.
Prognosi della malattia
Per chiunque sia malato di questa pericolosa malattia, viene prima di tutto una sola domanda: quanto tempo vive e se c'è una possibilità pieno recupero. È molto difficile fare una prognosi con una tale malattia; come già accennato, la malattia inizia a manifestarsi e ad essere diagnosticata solo nelle fasi successive.
Secondo la pratica attuale, la sopravvivenza per qualsiasi tipo di cancro è espressa nella probabilità di vita del paziente in un determinato periodo di tempo. I medici distinguono tra un periodo di cinque e dieci anni. Ma questo non significa che il malato possa morire dopo questo periodo. Molto spesso, un paziente che ha vissuto questo periodo, continua a sentirsi bene e a vivere una vita piena.
I medici identificano i seguenti importanti fattori che incidono direttamente sulla longevità del paziente:
- età del paziente. La pratica dimostra che quanto più il paziente è anziano, tanto più meno possibilità si prevede che si riprenderà completamente;
- sesso della persona malata. La prognosi sul decorso della malattia è più positiva nelle donne: sono loro che guariscono più spesso;
- È necessario prestare attenzione al numero di globuli bianchi. Più alto è il loro livello, minori sono le possibilità di una lunga vita;
- tipo di leucemia.
Inoltre, la prognosi dipende dal livello di risposta del corpo del paziente al trattamento chemioterapico. Ma in ogni caso, con l'intervento corretto e, soprattutto, tempestivo della medicina, c'è una possibilità di sopravvivenza.
Il trattamento stesso viene eseguito in tre fasi principali:
- Raggiungere la remissione. Questa è la fase principale durante la quale (di solito diverse settimane) viene eseguita la chemioterapia con citostatici.
- Consolidamento della remissione. In questo momento, le sostanze chimiche necessarie vengono somministrate per via endovenosa. Questa fase dura diversi mesi, a seconda delle condizioni del paziente e dello stadio della malattia stessa.
- Terapia di mantenimento. Queste procedure possono durare da due a tre anni. In questo caso, il paziente assume citostatici sotto forma di compresse.
È molto importante capire che anche dopo il trattamento completo esiste un'alta probabilità che la malattia ritorni. Tra gli specialisti, questo caso è chiamato “leucemia secondaria”. Questa probabilità è molto alta quando la chemioterapia viene somministrata a un tumore precedente. Ma anche la “leucemia secondaria” si può sconfiggere; è importante individuare per tempo la malattia. Pertanto, durante la terza fase del trattamento, dovresti essere costantemente sotto la supervisione di un medico.
Una malattia così terribile! Ma per qualche motivo ho pensato che fosse quasi incurabile, ma si è scoperto che le possibilità di recupero sono piuttosto alte. Quali fattori possono scatenare la comparsa della leucemia acuta?
Ciao Svetlana. I fattori possono includere radiazioni, esposizione costante a sostanze chimiche, inclusi antibiotici, malattie virali infettive e una componente genetica.
La leucemia linfoblastica acuta (LLA) è un gruppo di neoplasie maligne eterogenee di cellule precursori linfoidi (linfoblasti) con determinate caratteristiche genetiche e immunofenotipiche. Anomalie secondarie della differenziazione cellulare, della proliferazione o di entrambe portano ad un aumento della produzione e dell'accumulo di linfoblasti nel midollo osseo e alla loro infiltrazione nei linfonodi e negli organi parenchimali. Oltre l'80% di tutte le leucemie (leucemie) nei bambini sono di origine linfoide.
introduzione
La LLA è il tumore infantile più comune e rappresenta circa il 25% di tutte le neoplasie pediatriche. L'incidenza nei paesi sviluppati è di 3-4 casi ogni 100mila bambini all'anno. Un'incidenza minore di LLA si osserva nei paesi dell'Africa e dell'Asia centrale; è più comune in Cina, Giappone, Stati Uniti ed Europa. Il picco di incidenza della LLA nei bambini si verifica all'età di 2,5-5 anni ("picco infantile"), i ragazzi sono più spesso colpiti (rapporto 1,6: 1 per la LLA della linea B e 4: 1 per la LLA della linea T). I fattori predisponenti per lo sviluppo della LLA comprendono l'età materna durante la gravidanza, la storia materna di morte fetale (possibili fattori ambientali sfavorevoli o predisposizione genetica), l'elevato peso alla nascita del bambino (più di 4000 g), l'esposizione pre e postnatale alle radiazioni ionizzanti, la presenza di cancro in famiglia o leucemia in un fratello, sindromi da instabilità cromosomica: sindrome di Down, atassia-telangectasia, neurofibromatosi, deficit di IgA, immunodeficienza variabile, sindrome di Shwachman, agammaglobulinemia congenita legata all'X, anemia di Fanconi.
La mancanza di chiari collegamenti con fattori genetici e ambientali ha portato a supporre che lo sviluppo della LLA, così come di altri tumori, avvenga in presenza di mutazioni spontanee delle cellule progenitrici normali e successiva esposizione a fattori ambientali scatenanti che promuovono la proliferazione maligna ( J. Ochs, 1989; E. Olah, 1997; E. Panzer-Grumauer, 2000).
Diagnostica
Nella diagnosi di tutte le malattie oncologiche vengono presi in considerazione i segni clinici e le caratteristiche delle cellule che compongono il substrato tumorale. La diagnosi di leucemia linfoblastica acuta viene effettuata sulla base dell'anamnesi, dell'esame fisico e paraclinico, nonché dei parametri di laboratorio.
Le caratteristiche cliniche della ALL sono una combinazione di diverse sindromi principali.
1. Sindrome da intossicazione: debolezza, febbre, malessere, perdita di peso. La febbre può anche essere associata alla presenza di un'infezione batterica, virale, fungina o protozoaria (meno comunemente), soprattutto nei bambini con neutropenia (meno di 1500 neutrofili per 1 μl).
2. Sindrome iperplastica: aumento in tutti i gruppi linfonodi periferici sotto forma di conglomerati palpabili, densi e indolori. L'infiltrazione del fegato e della milza porta all'epatosplenomegalia, che può manifestarsi come dolore addominale. L'infiltrazione leucemica del periostio e della capsula articolare, gli infarti ossei e l'aumento del volume del midollo osseo del tumore causano dolore osseo. In questo caso, le radiografie rivelano cambiamenti caratteristici dell'infiltrazione leucemica, soprattutto nelle ossa tubolari, vicino alle grandi articolazioni. Il dolore può verificarsi più tardi, a causa dell'osteoporosi o della necrosi avascolare. La prima manifestazione della malattia può essere fratture patologiche delle ossa tubolari o della colonna vertebrale. Il dolore e il gonfiore articolare possono inizialmente essere scambiati per sintomi di artrite reumatoide o altre malattie e le lesioni ossee per osteomielite.
3. Sindrome anemica: pallore, debolezza, tachicardia, sanguinamento della mucosa orale, sindrome emorragica sulla pelle, pallore. La debolezza si verifica a causa di anemia e intossicazione.
4. La sindrome emorragica è associata sia a trombocitopenia che a trombosi intravascolare (soprattutto con iperleucocitosi) e porta alla comparsa di petecchie, ecchimosi sulla pelle e sulle mucose, emorragie, melena e vomito con sangue.
L'iniziale ingrandimento dei testicoli nei ragazzi si osserva nel 5-30% dei casi di LLA primaria; si tratta di infiltrati indolori, densi, unilaterali o bilaterali. La reale incidenza del coinvolgimento ovarico non è nota, ma alcuni studi stimano che sia compresa tra il 17% e il 35%. Ciò accade soprattutto spesso nell'iperleucocitosi e nella variante a cellule T della LLA (A. Friedmann, 2000; S. Pui, 2000).
Esistono casi di significativo ingrossamento dei reni a causa dell'infiltrazione leucemica, mentre i sintomi clinici del loro danno possono essere assenti.
Complicazioni rare comprendono l'infiltrazione miocardica e la pericardite da versamento dovuta all'ostruzione delle vie di drenaggio linfatico tra l'endocardio e l'epicardio.
Violazioni sistema respiratorio può essere associato ad ingrossamento dei linfonodi mediastinici, caratteristici della leucemia a cellule T, che portano allo sviluppo della sindrome della vena cava superiore o all'insufficienza respiratoria. Potrebbe esserci infiltrazione leucemica del tessuto polmonare e/o emorragie al suo interno. A volte è difficile differenziare queste complicazioni da un processo infettivo.
I segni più comuni di danno oculare nella LLA sono l'emorragia retinica, l'infiltrazione vascolare, il papilledema conseguente a neuroleucemia, la trombocitopenia e la coagulopatia. L'oftalmoscopia può rivelare placche leucemiche nel fondo.
Sulla pelle possono essere presenti elementi infiltrativi bluastri, densi e indolori (leucemi). Qualsiasi danno alla pelle è un punto di ingresso per l'infezione, quindi paronichia, cellulite, punture di insetti infetti e segni di iniezione possono essere un riscontro comune durante la diagnosi.
Studi paraclinici
1. Analisi del sangue generale.
Il livello di emoglobina può essere normale o basso, il numero dei globuli rossi e dell'ematocrito sono generalmente ridotti. C'è una diminuzione del numero dei reticolociti - Il numero dei globuli bianchi può essere normale, diminuito o aumentato e spesso, ma non sempre, si trovano cellule energetiche. Caratteristico è il “fallimento leucemico”: la presenza di cellule energetiche in assenza di forme intermedie di maturazione - mielociti e metamielociti nella formula del sangue.
Di norma, si osserva trombocitopenia, da piastrine insignificanti a singole.
2. Mielogramma. La puntura del midollo osseo deve essere eseguita da almeno due punti per ottenere un volume sufficiente di materiale diagnostico (di solito nei bambini si tratta delle creste posteriore e anteriore ossa iliache, nei bambini di età inferiore a 2 anni - ossa calcaneari o tuberosità tibiali), preferibilmente in anestesia generale. Con morfologico esame citologico di solito risulta essere ipercellulare Midollo osseo con germogli ristretti di emopoiesi normale e infiltrazione di blasti: dal 25% - una quantità sufficiente per fare una diagnosi di leucemia fino a quando non sostituiscono completamente il midollo osseo.
La fase successiva obbligatoria della diagnosi è uno studio citochimico che, utilizzando la colorazione citochimica, rivela l'appartenenza delle cellule a un determinato lignaggio. Assicurati di utilizzare la colorazione per mieloperossidasi (negativa nelle cellule appartenenti alla linea linfoide), PAS (acido periodico-Schiff) - spesso con la caratteristica colorazione diffusa o granulare del glicogeno nelle cellule energetiche. La colorazione del Sudan nero è raramente positiva nei linfoblasti e la fosfatasi acida può essere rilevata nella leucemia a cellule T (R. Lenskaya, 1980).
Attualmente, uno dei principali studi che determinano l'identità cellulare della popolazione dominante e la prognosi della malattia è l'immunofenotipizzazione. Le differenze nei marcatori superficiali e citoplasmatici dei linfociti T e B vengono utilizzate per identificare e classificare l'origine e lo stadio di differenziazione di tutte le malattie linfoproliferative. Le cellule leucemiche di pazienti affetti da LLA esprimono sulla loro superficie molti antigeni proteici che compaiono in diversi stadi di maturazione dei precursori dei linfociti B o T. La scoperta di questi antigeni ha confermato la provenienza del clone leucemico da progenitori linfoidi normali, arrestati nelle prime fasi dell'ontogenesi. L'utilizzo di un pannello di anticorpi monoclonali per i cluster di differenziazione e la determinazione della percentuale della loro espressione nella popolazione di controllo ci consente di indicare a quale linea (T o B) appartiene il clone leucemico in un dato paziente. La divisione dei linfoblasti nella LLA in gruppi eterogenei secondo stadi di maturazione e marcatori immunologici di superficie è attualmente un importante fattore determinante (J. Basso, 1994; J. Ciudad, 1998; S. Pui, 1998). Per la LLA della linea B, i fattori che determinano la tattica terapeutica sono l'età, la leucocitosi iniziale e le anomalie citogenetiche. La LLA a cellule T rimane oggetto di studi approfonditi, poiché essa stessa ha una prognosi sfavorevole e richiede un trattamento più intensivo. Di norma, la T-ALL è caratterizzata da età avanzata, presenza di lesioni extramidollari e elevata leucocitosi.
3. Puntura spinale. Obbligatorio evento diagnostico, che va effettuata da uno specialista sotto sedazione e in presenza di piastrine nel sangue periferico di almeno 30mila per 1 μl (se necessario, prima della puntura va effettuata la trasfusione di una sospensione di trombo). Per preparare il citopreparato sono necessari almeno 2 ml di liquido cerebrospinale. Quando la citosi è superiore a 5 cellule per microlitro e la presenza di cellule di controllo nel citocampione e/o sintomi di danno ai nervi cranici, al paziente viene diagnosticata una "lesione leucemica del sistema nervoso centrale (SNC)" - neuroleucemia. Tuttavia, si verifica sempre la penetrazione dei linfoblasti nel sistema nervoso centrale e l'infiltrazione delle meningi, anche in assenza di manifestazioni cliniche e di laboratorio. È auspicabile e in presenza di sintomi neurologici è obbligatorio eseguire una tomografia computerizzata o una tomografia nucleare magnetica del cervello e/o una tomografia nucleare magnetica del midollo spinale.
4. L'ecografia della cavità addominale e dello spazio retroperitoneale specifica la dimensione degli organi parenchimali infiltrati, dei linfonodi ingrossati della cavità addominale e di altre aree, dei testicoli e degli organi pelvici.
5. La radiografia del torace in due proiezioni è necessaria per rilevare l'ingrossamento del mediastino. Se indicato, vengono eseguite radiografie delle ossa e delle articolazioni.
6. Un esame del sangue biochimico di solito dimostra un aumento di LDH superiore a 500 UI, possibile disfunzione dei reni e del fegato.
7. ECG ed EchoCG sono richiesti prima di iniziare la chemioterapia.
Recentemente, metodi citogenetici e genetici molecolari sono stati utilizzati per studiare le cellule leucemiche per determinare il numero di cromosomi e i loro cambiamenti strutturali (traslocazione, inversione, delezione). Il rilevamento di anomalie citogenetiche e l'indice del DNA (il rapporto tra la quantità di DNA nelle cellule leucemiche e nelle cellule con un cariotipo diploide normale) si sono rivelati importanti fattori prognostici (LMatherly, 1997; M. Loh, 1998).
Il cromosoma Philadelphia (cromosoma Ph) è un'anomalia citogenetica caratterizzata dalla delezione o traslocazione del cromosoma 22q11. Si riscontra più spesso come traslocazione t ed è stata descritta per la prima volta nella leucemia mieloide cronica. Si verifica nel 3-5% dei bambini e nel 25% degli adulti affetti da LLA. La LLA Ph+ ha una prognosi sfavorevole, con tassi di sopravvivenza inferiori al 20% negli adulti e al 25-30% nei bambini. Più spesso si tratta di bambini più grandi, con iperleucocitosi, TUTTI con fenotipo della linea B. Può verificarsi una fase di remissione, proprio come nella LLA Rh, ma poi si verifica una ricaduta precoce. I bambini sotto i 10 anni, con leucocitosi inferiori a 25mila in 1 μl e una buona risposta al 7° giorno di trattamento hanno una probabilità di sopravvivenza del 50%. Esistono prove che uno dei motivi della prognosi sfavorevole è la lenta risposta alla terapia di induzione in quasi la metà (46%) dei pazienti e l'alto tasso di ricadute. In termini di trattamento di questi pazienti, nei primi 6 mesi di malattia viene data preferenza al trapianto di midollo osseo allogenico proveniente da un donatore familiare compatibile, che riduce il rischio di morte tossica e di recidiva. Il trapianto autologo di midollo osseo o il trapianto di midollo osseo da donatore non consanguineo non presenta vantaggi rispetto alla chemioterapia intensiva a causa dell'elevata incidenza di morti tossiche (S. Schlieben, 1996; S. Pui, 1999).
Un altro noto fattore sfavorevole è la presenza di traslocazione t. Di solito si verifica nei bambini di età superiore ai 10 anni con un fenotipo di lignaggio B. Nonostante la terapia intensiva, il tasso di sopravvivenza di questi pazienti è di circa il 40%.
La traslocazione t viene rilevata nel 68-81% dei bambini di età inferiore a un anno utilizzando metodi biologici molecolari ed è un segno sfavorevole.
L'indice o la ploidia del DNA viene misurato mediante citometria a flusso. L'iperploidia o l'indice del DNA >1,16 (più di 50 cromosomi in una cellula tumorale) si verificano nel 20% dei bambini più di un anno indipendentemente dalla leucocitosi iniziale e dall'età ed è associato a una buona prognosi. Determinare l'indice del DNA è più semplice che condurre un'analisi citogenetica completa, quindi questo indicatore viene preso in considerazione in quasi tutti i moderni protocolli di trattamento per LLA. Si presuppone che in questo caso si trovino nella fase S un numero significativamente maggiore di cellule e che siano più sensibili ai farmaci citostatici. Un'altra caratteristica citogenetica favorevole è stata la rilevazione del gene TEL/AML1, il risultato della traslocazione t. Si ritiene che l'espressione di TEL/AML1 nella LLA sia un indicatore di una buona prognosi e di una remissione a lungo termine. La sopravvivenza libera da recidiva di questi pazienti può raggiungere il 100% (D. Pinkel, 1996; M. Schorin, 1994, S. Sallan, 2004).
Con lo sviluppo delle tecnologie biologiche molecolari, sta avanzando lo studio della malattia minima residua (MRD). Questo termine si riferisce alla presenza di cellule leucemiche residue in un paziente in remissione. La tecnica per rilevare la MRD consiste nell'identificare le cellule con anomalie del cariotipo utilizzando metodi citogenetici (è possibile rilevare una cellula anormale su 100 cellule normali), polimerasi reazione a catena(consente di rilevare da 1 a 105 cellule normali). La citometria a flusso è un metodo molto sensibile per rilevare l'immunofenotipo anomalo. Sebbene la MRD sia oggetto di ricerca, sono ora emerse prove riguardo alla sua importanza nel causare ricadute. Pertanto, è noto che la definizione alto livello La MRD dopo l'induzione della remissione o prima della terapia di mantenimento è correlata a una prognosi sfavorevole. Nei moderni protocolli di trattamento per la LLA, alcune anomalie citogenetiche fungono da linee guida per determinare la tattica e l'intensità della terapia (A. Stackelberg, 2004; S. Raynaud, 1999).
Neuroleucemia
Già nel 1944 Evans individuò la presenza di un'evidente infiltrazione di tumore meningeo nei bambini affetti da LLA. Nel 1945, durante l'autopsia furono trovate prove microscopiche di danno leucemico al sistema nervoso centrale nell'83% dei pazienti con LLA, sebbene i sintomi fossero notati solo nel 35% dei casi. Dopo aver implementato un efficace prevenzione precoce neuroleucemia, la frequenza delle sue manifestazioni cliniche è diminuita dal 56% al 10%.
Le cellule leucemiche possono entrare nel sistema nervoso centrale attraverso la circolazione sistemica, cioè migrando attraverso l'endotelio venoso e nei siti di emorragia petecchiale (una trombocitopenia profonda alla diagnosi è associata ad un'elevata incidenza di neuroleucemia).
La capacità delle cellule leucemiche del sistema nervoso centrale di ripopolare il midollo osseo è un anello importante nel concetto di neuroleucemia. Infatti, in assenza di prevenzione della neuroleucemia, la neurorecidiva è la causa più comune di fallimento del trattamento e porta a una recidiva del midollo osseo e a una ridotta sopravvivenza. Attualmente, recidive isolate nel sistema nervoso centrale si verificano con una frequenza del 5-11% in vari protocolli. Molti studi dimostrano che l’intensificazione della terapia intratecale senza l’uso di radiazioni previene il verificarsi di neurorecidive nei bambini con rischio standard e medio di LLA. Grande importanza è anche attribuita all'uso nella chemioterapia sistemica di farmaci che penetrano bene nel sistema nervoso centrale: metotrexato a dosi medie e alte, desametasone, uso a lungo termine di L-acaraginasi. Per i pazienti appartenenti a gruppi ad alto rischio, l'irradiazione cranica rimane rilevante, poiché, nonostante ciò, in questi pazienti si verificano neuroricadute (S. Buhrer, 1990; G. Henze, 1999).
Trattamento
Il principio di base della moderna oncoematologia pediatrica è la divisione dei pazienti in gruppi in base all'intensità della terapia utilizzata, a seconda della prognosi attesa. Coloro che possono essere curati con una chemioterapia moderata non dovrebbero ricevere una terapia più severa e tossica, e per coloro la cui probabile sopravvivenza è bassa, l’intensificazione della chemioterapia può rappresentare una possibilità di cura. I pazienti vengono suddivisi in gruppi in base alle caratteristiche prognostiche individuate sulla base dell'esperienza pregressa e inserite nei sistemi di classificazione dei singoli protocolli. Sulla base di ciò, ciascun protocollo determina una strategia terapeutica di una intensità o di un'altra. Nonostante la varietà delle classificazioni, esiste un accordo generale sulla suddivisione dei pazienti in gruppi a rischio (vedi tabella).
Un altro parametro che dovrebbe essere studiato in tutti i pazienti è il tasso di risposta primaria alla chemioterapia, determinato dal numero di blasti nel midollo osseo e/o nel sangue al 14° (8°) giorno di trattamento (R. Ribeiro, 1997; G. Henze, 1995).
All'età fino a un anno (circa il 4% dei casi di nuova diagnosi), la LLA è una forma estremamente aggressiva della malattia, caratterizzata da elevata leucocitosi, neuroleucemia, ingrossamento degli organi parenchimali, immunofenotipo pre-B delle cellule di controllo, CD10- . In più del 50% dei casi, queste cellule presentano anomalie associate al braccio lungo del cromosoma 11 nella regione q23. I risultati del trattamento sono molto peggiori rispetto alla popolazione generale dei pazienti (il tasso di sopravvivenza è solo del 20-30%), quindi gli approcci terapeutici continuano ad essere discussi (introduzione della terapia con citosar ad alte dosi, trapianto allogenico di midollo osseo nella prima remissione) (S Pui, 1999; S. Sallan, 2004).
I principi di base del trattamento della LLA nei bambini sono stati sviluppati alla fine degli anni '60 negli Stati Uniti. Infatti, finora non hanno subito modifiche e comprendono l'induzione della remissione con i principali farmaci - vincristina e prednisolone, l'uso della somministrazione endolombare di metotrexato
(MTX) e irradiazione cranica per la prevenzione della neuroleucemia, l'uso di 6-mercaptopurina (6-MP) e MTX per la terapia di mantenimento in remissione. È stato sviluppato un programma di trattamento per TUTTI. Ciò significava che tutti i pazienti venivano trattati con dosi chiaramente definite e combinazioni di farmaci chemioterapici in modo rigorosamente controllato. scadenze, secondo il relativo protocollo.
Alla fine degli anni '70 divenne chiaro che circa il 50% dei bambini affetti da LLA potevano essere curati con questa terapia. Ulteriori progressi nel trattamento della LLA sono stati associati all'identificazione dell'eterogeneità biologica della LLA e all'introduzione sistema internazionale classificazione citologica (FAB), introduzione di un sistema di fattori prognostici, divisione dei pazienti in gruppi a rischio e sviluppo di programmi di trattamento differenziati, organizzazione di studi multicentrici e gruppi clinici cooperativi, sviluppo della ricerca nel campo della farmacocinetica di vari farmaci citostatici al fine creare regimi chemioterapici più efficaci, sviluppo intensivo della terapia di accompagnamento (D. Poplack, 1991; M. Abromowich, 1998).
Tutto ciò ha portato alla creazione della prossima generazione di programmi di chemioterapia per TUTTI. La maggior parte dei protocolli moderni per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta nei bambini si basano sui principi della chemioterapia iniziale intensiva per la massima distruzione del pool di cellule leucemiche. L'ideologia dietro la creazione di tutti questi programmi è l'uso di farmaci citostatici sotto forma di combinazioni alternate (rotazione), l'uso di regimi chemioterapici ad alte dosi e la prevenzione intensiva della neuroleucemia. I principali metodi di prevenzione e trattamento della neuroleucemia sono la somministrazione intratecale di farmaci chemioterapici (metotrexato, citosar, prednisolone) in dosaggi specifici per età e l'irradiazione cranica nelle prime fasi del trattamento. È prevista anche la somministrazione endolombare di metotrexato impatto sistemico Pertanto, per ridurre la massa tumorale, è obbligatoria una prima puntura lombare terapeutica precoce. L'irradiazione cranica ha effetti collaterali immediati e a lungo termine, quindi ricerca moderna per ottimizzare il trattamento della LAL sono mirati a ridurre la dose di radiazioni e ad identificare con precisione i pazienti nel gruppo a basso rischio, per i quali la radioterapia non è necessaria. Questi risultati hanno consentito negli Stati Uniti e in Europa occidentale di superare la barriera del 70% di sopravvivenza libera da malattia a 5 anni per la LAL nei bambini entro la fine degli anni ’80. I migliori protocolli attualmente utilizzati includono quelli creati dal gruppo BFM (Germania), presentati in questo articolo, nonché una serie di protocolli americani (P. Gaynon, 1990; G. Henze, 1991). Sulla base dei risultati del trattamento nell'ambito di questi programmi ottenuti dal gruppo BFM, nonché dell'esperienza accumulata in Russia (Istituto di ricerca di ematologia pediatrica del Ministero della sanità della Federazione Russa, Direttore - Membro corrispondente dell'Accademia russa di medicina Sciences A. Rumyantsev), è stato sviluppato un protocollo originale per il trattamento della LLA nei bambini, chiamato "Mosca - Berlino 91" (ALL-MB 91). L'idea principale di questo programma di chemioterapia era l'idea del ruolo chiave della neuroleucemia nell'insorgenza di ricadute e, di conseguenza, fallimenti nel trattamento della LLA nei bambini. A questo proposito, il prednisolone è stato sostituito dal desametasone, un regime di uso a lungo termine (per diversi mesi) di asparaginasi e la chemioprofilassi locale della neuroleucemia con tre farmaci sono stati introdotti durante il 1° anno di terapia. Requisiti speciali per il nuovo protocollo erano il rifiuto di utilizzare la chemioterapia intensiva ad alte dosi e, di conseguenza, il trattamento dei pazienti in ambito ambulatoriale, riducendo la necessità di terapie di accompagnamento e trasfusioni di componenti del sangue, nonché eliminando l'irradiazione cranica nella maggior parte dei pazienti.
Il trattamento moderno della LLA consiste in diverse fasi principali: induzione della remissione con l'aiuto di 3 o più agenti somministrati nell'arco di 4-6 settimane, consolidamento multiagente (“consolidamento”) della remissione e terapia di mantenimento, solitamente con antimetaboliti, per 2- 3 anni.
La terapia di accompagnamento può prevenire e trattare molte complicazioni associate all’immunosoppressione e alla citopenia indotta.
La necessità di una terapia di mantenimento a lungo termine per 2-3 anni è stata dimostrata negli anni '50 del secolo scorso. Tipicamente, questa terapia consiste nell'assunzione giornaliera di 6-marcaptopurina e di metotrexato settimanale, con dosi modificate in base alla conta dei globuli bianchi. La tollerabilità di questo regime è generalmente soddisfacente; la necessità di impulsi di reinduzione in questo contesto (ad esempio, desametasone + vincristina) è dibattuta. È stato dimostrato che la terapia di mantenimento in un volume inferiore all'80% del necessario (con interruzioni forzate per complicanze o dosaggio inadeguato) costituisce un fattore prognostico sfavorevole per lo sviluppo di recidive (G. Henze, 2000; D. Pinkel, 1999 ).
I principali problemi nel trattamento della LLA sono il numero crescente di pazienti con cloni mutanti di cellule tumorali resistenti alla chemioterapia, gli effetti collaterali tardivi della terapia (disturbi della crescita, problemi neuroendocrini, secondi tumori) e gli alti costi del trattamento. Il fallimento della terapia di induzione è associato alla morte prematura dei pazienti a causa di complicazioni tossiche o con un tumore resistente. Gli approcci al trattamento dei pazienti che non hanno risposto alla terapia sono limitati; citosar, Vepezid e teniposide sono utilizzati come regime alternativo.
Lo stato di remissione è definito come l'assenza di cellule magistrali nel sangue, meno del 5% di blasti nel midollo osseo con segni di ripristino della normale emopoiesi e meno di 5 cellule mononucleate per microlitro nell'analisi del liquido cerebrospinale. Il rapido raggiungimento della remissione è essenziale per il successo della terapia. Nel 90% dei pazienti, le cellule leucemiche sono altamente sensibili alla chemioterapia e nell'85-90% dei casi si ottiene la remissione, il che significa che il 99,9% delle cellule viene distrutto. L'obiettivo principale della terapia è curare il paziente e riportarlo alla normale vita sociale e in buona salute con il minimo degli effetti collaterali legati al trattamento. Ciò è difficile da raggiungere, poiché tutti i farmaci antileucemici finora utilizzati sono tossici e non sufficientemente selettivi. Tuttavia, i progressi nella comprensione dell’eterogeneità biologica e clinica della LLA e gli studi di biologia molecolare promettono di essere decifrati patogenesi molecolare di questa malattia. Quindi la conoscenza del meccanismo della trasformazione maligna ci consentirà di trovare forme di trattamento più efficaci e meno tossiche.
SGR - gruppo di rischio standard; SGR - gruppo a rischio medio; VGR - gruppo ad alto rischio; protocollo 1 - induzione della remissione (vincristina, prednisolone, L-asparaginasi, daunorubicina, ciclofosfamide, citosar, MTX endolombare); protocollo M - MTX ad alte dosi (4 “colpi”) durante l'assunzione di 6MP; protocollo 2 - reinduzione (vincristina, desametasone, L-asparaginasi, adriablastina, ciclofosfamide, citosar, MTX endolombare); blocchi HR1, 2, 3 - blocchi di polichemioterapia intensiva ad alte dosi.
Veniamin CHERNOV, dottore Scienze mediche. Istituto di ricerca di ematologia pediatrica del Ministero della sanità e dello sviluppo sociale della Russia.
Leucemia
Leucemia (leucemia, cancro del sangue) è una malattia neoplastica maligna clonale del sistema emopoietico. Le leucemie comprendono un ampio gruppo di malattie di varia eziologia in cui si verifica la clonazione maligna di cellule ematopoietiche immature del midollo osseo.
In generale, la leucemia è una malattia rara, che colpisce circa 1 persona su 50mila. Tuttavia, le statistiche degli ultimi anni ci permettono, purtroppo, di parlare di un aumento del tasso di incidenza in tutto il mondo.
Fattori eziologici
Fattori genetici. Secondo le statistiche, esiste la possibilità sia di trasmissione diretta dei geni della leucemia sia attraverso una generazione. Vi è un notevole aumento nella diagnosi di eritromielosi acuta e leucemia mieloide cronica nelle famiglie con patologie cromosomiche ereditarie, come la sindrome di Down, la sindrome di Turner, la sindrome di Fanconi, la sindrome di Bloom, la sindrome di Klinefelter, ecc. Sono frequenti i casi di sviluppo della leucemia con vari difetti ereditari dell'immunità - sindrome di Louis-Barre, sindrome di Bruton , Wiskot-Aldrich, con linfosarcoma e leucemia linfoblastica acuta più spesso diagnosticati.
Azione degli agenti chimici che aumentano il rischio di sviluppare la leucemia (citostatici, cefalosporine, antibiotici penicillinici, prodotti chimici domestici, alcuni componenti di tappeti e linoleum, ecc.).
Radiazione ionizzante. Molti studi hanno dimostrato la possibilità di una partecipazione diretta delle radiazioni ionizzanti al meccanismo del danno cromosomico, che successivamente porta allo sviluppo della leucemia.
Fattori infettivi e virali. Si presume che oltre un centinaio di virus siano blastomogenici. Tra questi ci sono sia virus contenenti RNA che virus contenenti DNA. I virus blastogenici contenenti RNA includono virus del sarcoma di Rous, eritroblastosi, mieloblastosi, virus della leucemia del topo, virus della leucemia aviaria, ecc. Tra i virus contenenti DNA, i medici considerano i virus più importanti del gruppo dell'herpes, del gruppo dei papovavirus, del gruppo del vaiolo, ecc.
Le metastasi si trovano sotto forma di infiltrati nella milza, nel fegato, nei linfonodi, ecc. È anche comune lo sviluppo di alterazioni causate dall'ostruzione dei vasi sanguigni da parte delle cellule tumorali (infarti e alterazioni ulceroso-necrotiche).
Classificazione
Secondo la natura del flusso:
Acuto(che si sviluppa da esplosioni - cellule immature);
Cronico(che si sviluppa da cellule mature e in maturazione).
Vale la pena notare che questi termini sono usati esclusivamente per comodità, poiché la leucemia acuta non si trasforma in nessuna circostanza in cronica e la leucemia cronica non si trasforma mai in leucemia acuta. Il significato di questi termini in ematologia differisce in modo fondamentale dal loro significato nel senso comune.
Secondo il grado di differenziazione delle cellule maligne:
Raffica;
Indifferenziato;
Citato.
In base alla citogenesi le leucemie acute si dividono in:
Mieloblastico;
Linfoblastico;
Monoblastico;
Eritromieloblastico;
Mielomonoblastico;
Megacarioblastico;
Indifferenziato.
La leucemia cronica è divisa in malattie:
Origine mielocitica(leucemia mielocitica cronica, leucemia eosinofila cronica, leucemia neutrofila cronica, leucemia basofila cronica, eritremia/policitemia vera, mielosclerosi, trombocitopenia essenziale);
Origine linfocitaria– leucemia linfocitica cronica, leucemia paraproteinemica (macroglobulinemia primaria di Waldenström, mieloma, malattia delle catene pesanti di Franklin, malattia di Sézary – linfomatosi della pelle);
Origine dei monociti(istiocitosi X, leucemia monocitica cronica, leucemia mielocitica cronica).
Considerando questa classificazione si può evidenziare il relativo passaggio delle forme leucemiche croniche a quelle acute, cioè con l'azione prolungata di alcuni fattori eziologici, oltre ai disturbi delle cellule precursori della mielo-o linfopoiesi, lo sviluppo si verificano anche cambiamenti caratteristici della leucemia acuta.
Inoltre, il moderno livello di diagnostica ha permesso di effettuare una tipizzazione più accurata delle cellule maligne in base a vari marcatori antigenici (ad esempio, catene leggere di immunoglobuline).
Dalla presenza di blasti nel sangue periferico e da numero totale leucociti:
Leucemico– oltre 50-80×10 9 /l leucociti, compresi i blasti;
Subleucemico– 50-80×10 9 /l leucociti, compresi i blasti;
Leucopenico– nel sangue periferico il contenuto dei leucociti è inferiore al normale, ma sono presenti blasti;
Aleucemico(nel sangue periferico il contenuto dei globuli bianchi è ridotto, i blasti non vengono rilevati).
Patogenesi e sintomi
Il tessuto tumorale nella leucemia si sviluppa inizialmente nel midollo osseo, sostituendo gradualmente i normali germi emopoietici. Di conseguenza, i pazienti manifestano in modo del tutto naturale varie citopenie, vale a dire trombocitopenia, anemia, granulocitopenia, linfocitopenia. Tutto ciò porta a emorragie, aumento del sanguinamento e uno stato di immunodeficienza, nonché, come conseguenza di quest'ultimo fattore, complicazioni infettive.
Di norma, la leucemia acuta si manifesta rapidamente, con un quadro sanguigno caratteristico causato da una rottura in un certo stadio dell'ematopoiesi. Di conseguenza, i blasti non maturano in cellule del sangue mature, il che si manifesta con blastemia in assenza di forme transitorie e un piccolo numero di leucociti maturi. Di solito si manifesta con la febbre.
La leucemia cronica è relativamente benigna. Nel corso del tempo, l'anemia si sviluppa a causa della soppressione della normale funzione ematopoietica del midollo osseo rosso. La produzione di anticorpi autoaggressivi viene interrotta, il che porta alla distruzione dei globuli rossi e talvolta delle piastrine. Sono tipici vari tipi di sanguinamento. Con lo sviluppo di complicazioni: febbre, esaurimento, sudorazione, crescente debolezza generale, dolore osseo, ecc.
Caratteristiche morfologiche
Con un elevato blocco di differenziazione, le cellule leucemiche possono assomigliare alle cellule staminali e ai blasti delle prime quattro classi di cellule progenitrici. Pertanto, a seconda del grado di differenziazione, queste leucemie vengono chiamate blastiche e indifferenziate. Poiché si manifestano in modo acuto, possiamo dire che le leucemie acute sono leucemie blastiche e indifferenziate.
Con un basso blocco di differenziazione, le cellule leucemiche assomigliano alle cellule procitiche e precursori procitici; la leucemia è meno maligna, cronica e viene chiamata citica.
I principali segni clinici della leucemia acuta:
un gran numero di blasti e il loro vantaggio (più del 30%, solitamente 60-90%);
"fallimento leucemico" - la scomparsa di forme intermedie di cellule sullo sfondo di un gran numero di esplosioni;
presenza simultanea di abasofilia e aneosinofilia;
anemia rapidamente progressiva.
I principali segni clinici della leucemia cronica (i segni sono gli stessi, ma esattamente l'opposto):
un piccolo numero di blasti o la loro assenza (meno del 30%, più spesso 1-2%);
assenza di “insufficienza leucemica”, cioè presenza di forme cellulari intermedie (promielociti e mielociti);
associazione basofila-eosinofila, cioè presenza contemporanea di basofilia ed eosinofilia;
anemia lentamente progressiva con un aumento della velocità del suo sviluppo durante il periodo della sua esacerbazione.
Nella diagnostica
Nella leucemia, l'esame morfologico è di grande importanza. I principali metodi di diagnosi morfologica intravitale sono gli studi su strisci di sangue periferico e biopsie del midollo osseo, che vengono ottenuti durante la trapanazione della cresta iliaca o la puntura dello sterno, così come di altri organi.
Leucociti (sono anche globuli bianchi, globuli bianchi). La funzione principale è fornire protezione al corpo dagli effetti di agenti estranei, nonché partecipazione diretta alla lotta contro i processi associati alle malattie infettive.
Piastrine (sono anche globuli rossi, globuli rossi). In questo caso la funzione principale è garantire il trasferimento dell'ossigeno e di altri tipi di sostanze ai tessuti del corpo.
Piastrine (sono anche piastrine del sangue). La loro funzione principale è quella di partecipare al processo che garantisce la coagulazione del sangue. Va notato l'importanza di questa funzione per il sangue così come è considerata nella forma reazione difensiva, necessario per l'organismo in caso di significativa perdita di sangue accompagnata da danno vascolare.
tipi di leucemia:
Leucemia linfocitica cronica(o leucemia linfocitica cronica, leucemia linfocitica cronica) è un tipo di cancro del sangue che è accompagnato da una ridotta divisione dei linfociti nel midollo osseo e da una ridotta maturazione.
Leucemia mielocitica cronica(o leucemia mieloide cronica, leucemia mielocitica cronica) è un tipo di cancro del sangue, il cui decorso porta all'interruzione della divisione delle cellule del midollo osseo e all'interruzione della loro maturazione, e queste cellule in questo caso agiscono come forme più giovani di sangue rosso cellule, piastrine e leucociti.
(o leucemia linfocitica acuta, leucemia linfoblastica acuta) - il decorso del cancro del sangue in questo caso è caratterizzato da una violazione della divisione dei linfociti nel midollo osseo, nonché da una violazione della loro maturazione.
Leucemia linfoblastica acuta(o leucemia mieloide acuta, leucemia mieloblastica acuta) - in questo caso, il cancro del sangue è accompagnato da una ridotta divisione delle cellule del midollo osseo e da una ridotta maturazione; queste cellule agiscono come forme più giovani di globuli rossi, piastrine e leucociti. In base al tipo di cellule coinvolte nel processo patologico, nonché in base al grado di interruzione della loro maturazione, si distinguono seguenti tipi Il decorso di questa forma di cancro:
leucemia senza concomitante maturazione cellulare;
leucemia, in cui la maturazione cellulare non avviene completamente;
leucemia promieloblastica;
leucemia mielomonoblastica;
leucemia monoblastica;
eritroleucemia;
leucemia megacarioblastica.
Leucemia: sintomi
Le manifestazioni dei sintomi che accompagnano la malattia in esame, come abbiamo notato inizialmente, sono determinate dalle caratteristiche e dall'entità della diffusione delle cellule tumorali, nonché dal loro numero totale. La leucemia cronica in fase iniziale, ad esempio, è caratterizzata da un piccolo numero di cellule tumorali, che per questo motivo può essere accompagnata da un decorso asintomatico della malattia per lungo tempo. Nel caso della leucemia acuta, che abbiamo anche notato, i sintomi si manifestano precocemente.
Evidenziamo i principali sintomi che accompagnano il decorso della leucemia (in forma acuta o cronica):
ingrossamento dei linfonodi (principalmente quelli concentrati in ascelle o al collo), il dolore ai linfonodi nella leucemia è solitamente assente;
aumento dell'affaticamento, debolezza;
suscettibilità allo sviluppo di malattie infettive (herpes, bronchite, polmonite, ecc.);
temperatura elevata (senza fattori associati), aumento della sudorazione notturna;
dolori articolari;
ingrossamento del fegato o della milza, contro il quale, a sua volta, può svilupparsi una pronunciata sensazione di pesantezza nell'area dell'ipocondrio destro o sinistro;
disturbi associati alla coagulazione del sangue: lividi, sangue dal naso, punti rossi sotto la pelle, gengive sanguinanti.
Sullo sfondo dell'accumulo di cellule tumorali in alcune aree del corpo, compaiono i seguenti sintomi:
mal di testa;
nausea;
compromissione della coordinazione dei movimenti;
visione offuscata;
convulsioni in alcune aree;
la comparsa di gonfiore doloroso nella zona inguinale e negli arti superiori;
dolore allo scroto, gonfiore (negli uomini).
confusione;
Leucemia linfoblastica acuta: sintomi
La leucemia nei bambini, i cui sintomi si manifestano più spesso in questa forma della malattia, si sviluppa principalmente tra i 3 ei 7 anni; inoltre, è tra i bambini che questa malattia, purtroppo, è diventata più diffusa. Evidenziamo i principali sintomi rilevanti per TUTTI:
Intossicazione. Si manifesta con malessere, debolezza, febbre e si nota anche perdita di peso. La febbre può essere scatenata da un'infezione (virale, batterica, fungina o protozoaria (che è un po' meno comune)).
Sindrome iperplastica. Caratterizzato da un effettivo ingrossamento dei linfonodi periferici di tutti i gruppi. A causa dell'infiltrazione della milza e del fegato, aumentano di dimensioni, il che può essere accompagnato anche da dolore addominale. L'infiltrazione leucemica del periostio in combinazione con l'allargamento del tumore a cui è esposto il midollo osseo può causare sensazioni dolorose e dolori articolari.
Sindrome anemica. Si manifesta sotto forma di sintomi come debolezza, pallore, tachicardia. Inoltre compaiono gengive sanguinanti. La debolezza è una conseguenza dell'intossicazione e dell'anemia stessa.
Cambiamento iniziale delle dimensioni dei testicoli (ingrandimento). Si verifica in circa il 30% dei casi di forma primaria di LLA nei ragazzi. Gli infiltrati (aree di tessuto all'interno delle quali si formano elementi cellulari non caratteristici di essi, con un volume tipicamente aumentato e una densità aumentata) possono essere unilaterali o bilaterali.
Emorragie dentro retina, gonfiore del nervo ottico. In questo caso l'oftalmoscopia può spesso rivelare la presenza di placche leucemiche all'interno del fondo.
Disturbi respiratori. Sono causati dall'ingrossamento dei linfonodi nel mediastino che, a sua volta, può provocare insufficienza respiratoria.
A causa della ridotta immunità, danni di qualsiasi tipo, indipendentemente dall'intensità dell'esposizione, dall'area e dalla natura della lesione, costituiscono un focolaio di infezione sulla pelle.
Manifestazioni abbastanza rare, ma non escluse per questo motivo, includono complicazioni come il danno renale che si sviluppa sullo sfondo dell'infiltrazione e i sintomi clinici in questo caso possono essere assenti.
Leucemia mieloblastica acuta: sintomi
Questa malattia può manifestarsi a qualsiasi età, ma molto spesso viene diagnosticata in pazienti di età superiore ai 55 anni. Nella maggior parte dei casi, i sintomi caratteristici della leucemia mieloide acuta si manifestano gradualmente. Il primo segno della malattia è il malessere e può manifestarsi diversi mesi prima che si manifestino gli altri sintomi.
I sintomi di questa malattia sono inerenti alla precedente forma di leucemia e alla leucemia in generale. Qui si manifestano quindi le sindromi anemiche e tossiche di cui abbiamo già parlato, che si manifestano con vertigini, grave debolezza, aumento dell'affaticamento, scarso appetito, così come nella febbre senza fenomeni catarrali associati (cioè senza fattori specifici che la provocano: virus, infezioni, ecc.).
Nella maggior parte dei casi, i linfonodi non cambiano molto, sono di piccole dimensioni e indolori. Raramente si osserva il loro ingrossamento, che può determinarne le dimensioni entro 2,5-5 cm, con conseguente formazione di conglomerati (cioè in questo caso i linfonodi sono fusi tra loro in modo tale che appare un caratteristico "nodulo" ), concentrato nella regione cervicale, nell'area sopraclavicolare.
Anche il sistema osteoarticolare è caratterizzato da alcuni cambiamenti. Quindi, in alcuni casi, ciò significa dolore persistente che si manifesta nelle articolazioni degli arti inferiori, così come dolore concentrato lungo gli arti inferiori. colonna vertebrale, con conseguenti disturbi dell'andatura e del movimento. In questo caso, le radiografie determinano la presenza di cambiamenti distruttivi in varie aree di localizzazione, il fenomeno dell'osteoporosi, ecc. Molti pazienti sperimentano un certo grado di ingrossamento della milza e del fegato.
Ancora una volta, i sintomi generali sono rilevanti sotto forma di suscettibilità alle malattie infettive, comparsa di lividi con lievi contusioni o nessun impatto, sanguinamento di varie parti specifiche (uterino, gengivale, nasale), perdita di peso e dolore alle ossa (articolazioni) .
Le malattie oncologiche sono giustamente considerate la piaga del 21° secolo, non risparmiando né gli adulti né i bambini. Molto spesso, le cellule maligne colpiscono il sistema circolatorio, portando allo sviluppo della leucemia - cancro del sangue. Questa patologia ha una varietà di forme e segni clinici. Secondo le statistiche, la leucemia linfoblastica acuta è considerata la più comune.
Come si sviluppa la malattia
Cos’è la leucemia linfoblastica acuta? Questa è una patologia maligna che si forma nel midollo osseo rosso a causa della formazione, dell'aumento della crescita e della riproduzione incontrollata delle cellule linfocitarie maligne. Quindi colpiscono il sistema nervoso centrale, i linfonodi e la milza.
Ciò avviene come segue: durante l'ematopoiesi, a partire da una cellula staminale si formano i precursori della linfocitopoiesi e della mielopoiesi. Nel primo caso si formano (leucociti), nel secondo globuli rossi (eritrociti) e piastre del sangue (piastrine).
Durante la linfocitopoiesi si formano i linfociti T e B, dai quali hanno origine le cellule immature, i blasti. In questo caso, in qualsiasi momento può verificarsi un malfunzionamento, a causa del quale i blasti crescono e si moltiplicano in modo incontrollabile, interferendo con la formazione di cellule del sangue sane, che porta allo sviluppo di una forma acuta di leucemia linfoblastica.
Secondo la classificazione Organizzazione Mondiale Sanità, esistono quattro tipi di leucemia linfoblastica acuta: cellule pre-B, cellule pre-B, cellule B e cellule T.
La leucemia linfocitica acuta è il tumore più comune, diagnosticato più spesso nei bambini, soprattutto nei ragazzi. Le leucemie a cellule B rappresentano circa l’85% dei casi. Tipicamente, la leucemia linfocitica acuta colpisce pazienti di età compresa tra 1 e 6 anni (picchi a tre anni). La forma primaria di cancro viene rilevata durante l'infanzia. La leucemia linfoblastica acuta negli adulti, di regola, è una conseguenza della leucemia linfocitica cronica.
Il restante 15% è rappresentato dalla leucemia a cellule T, che colpisce soprattutto i pazienti adolescenti (il periodo di picco è considerato intorno ai 15 anni).
Cause di patologia maligna
Gli scienziati non hanno identificato le cause esatte del disturbo nella formazione delle cellule del sangue nel midollo osseo, che porta alla leucemia linfoblastica acuta.
Si ritiene che la leucemia linfoblastica acuta si sviluppi sotto l'influenza di diversi fattori:
- Esposizione alle radiazioni. Alloggio o lungo soggiorno nella zona radioattiva, frequenti esami a raggi X, radioterapia per il cancro. Gli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti sul corpo sono stati dimostrati dall'esempio delle statistiche sulla comparsa della leucemia tra i residenti in Giappone dopo il bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, così come dopo Incidente di Chernobyl. Nel 10% dei casi, la leucemia linfocitica viene rilevata nei pazienti affetti da cancro dopo aver subito un ciclo di radioterapia. Tuttavia, non esistono dati attendibili sul collegamento tra leucemia e radioterapia.
- Sostanze tossiche. Il benzene, utilizzato nella produzione industriale, è riconosciuto come il più dannoso, penetrando attraverso l'epidermide e gli organi respiratori e accumulandosi nei tessuti grassi e nervosi. Può influenzare direttamente il corpo, interrompendo il DNA delle cellule del sangue, o indirettamente attraverso i prodotti dell'elaborazione della sostanza da parte delle cellule del fegato. Grande quantità il benzene è presente nel fumo di sigaretta. Non di meno impatto negativo sono causati da pesticidi e altri prodotti chimici. L'uso frequente di candeggina e vernici tecniche da parte di una madre può portare allo sviluppo della leucemia linfocitica acuta in un bambino. Anche le sostanze chimiche contenute in alcuni farmaci possono causare il cancro del sangue.
- Malattie infettive. Il virus che causa la ALL non è stato ancora identificato. Tuttavia, un ruolo ipoteticamente importante nello sviluppo della leucemia linfocitica appartiene al retrovirus HTLV, che contiene geni che trasformano una cellula sana in cancerosa. Inoltre, i bambini con un sistema immunitario debole hanno caratteristiche diverse organismi patogeni possono diventare provocatori della leucemia linfoblastica acuta. Tuttavia, questo non ha prove scientifiche.
- Eredità. Tra i provocatori della leucemia linfoblastica ci sono patologie genetiche e malattie ereditarie: gli studi hanno dimostrato che quando viene rilevata la leucemia linfocitica in uno dei gemelli, nel 25% dei casi c'è il rischio che il secondo si ammali.
Un'alimentazione scorretta contribuisce anche allo sviluppo della leucemia linfocitica acuta. La leucemia linfoblastica acuta si verifica anche a causa della presenza di cibi in scatola, nonché di frutta e verdura ad alto contenuto di nitrati nella dieta di una donna incinta.
I fattori che provocano la leucemia linfoblastica acuta includono la presenza della sindrome di Down nei bambini e difetti cardiaci congeniti.
È notato sottocorrente leucemia linfocitica acuta, brillante sintomi gravi si rivelano dopo qualche anno. Questo è il pericolo della leucemia linfocitica acuta: da una forma latente la malattia spesso passa direttamente al quarto stadio. Ciò complica il trattamento, portando alla morte.
Come riconoscere il cancro
La leucemia linfoblastica acuta, i cui sintomi sono caratterizzati da un decorso latente, viene spesso diagnosticata in uno stadio progressivo, quando i linfoblasti si formano a un ritmo incredibile: a settimana - 3-4% del peso del paziente. La cosa principale è fermare la crescita delle cellule del sangue maligne il più rapidamente possibile.
Dovresti stare attento se osservi manifestazioni comuni di leucemia linfocitica acuta che sono caratteristiche di tutti:
- temperatura febbrile;
- affaticamento rapido; malessere costante;
- dolori articolari;
- derma pallido;
- eruzioni cutanee rosse sul corpo;
- disagio nell'area del fegato e della milza;
- frequenti malattie infettive;
- infiammazione dei linfonodi.
Tuttavia, a seconda del fattore provocante, esistono diversi tipi di sintomi della leucemia linfoblastica acuta:
- La sindrome da intossicazione si manifesta in un contesto di letargia, aumento dell'affaticamento, improvvisa perdita di peso e aumento della temperatura.
- La sindrome iperplastica si manifesta con l'ingrossamento dei linfonodi, del fegato e della milza. Il dolore frequente nella cavità addominale può indicare un danno agli organi interni: polmoni, reni, ecc. Una sensazione di dolore alla cartilagine e alle articolazioni, zoppia indica un danno al periostio e ai tessuti articolari.
- caratterizzato da aumento della frequenza cardiaca, vertigini costanti, pallore dell'epidermide, affaticamento rapido. Questi sintomi sono spesso complicati da segni di anemia.
- La sindrome emorragica è provocata da coaguli di sangue e trombocitopenia formati nei vasi. Si manifesta con piccole emorragie capillari sulla pelle e sulle mucose. I pazienti lamentano un aumento del sanguinamento dal naso, dalle gengive, dallo stomaco e dall'intestino. Anche le piccole abrasioni sanguinano a lungo.
- La sindrome infettiva si verifica quando si verifica un'infezione virale, batterica o fungina del sito di iniezione o una lesione cutanea traumatica minore.
Con una mancanza di globuli rossi, si osservano perdita di appetito, letargia e mancanza di interesse per qualsiasi cosa. Una carenza di globuli bianchi colpisce il sistema immunitario. A causa del suo indebolimento, il corpo del bambino diventa vulnerabile alle malattie infettive.
La mancanza di un numero sufficiente di piastrine porta a scarsa coagulazione del sangue, eruzioni cutanee e sanguinamento. I pazienti lamentano dolore agli organi interni.
Ciò suggerisce che le neoplasie linfoidi abbiano colpito il midollo osseo.
La forma acuta della leucemia linfocitica è pericolosa perché le cellule tumorali spesso colpiscono il cervello. Ciò porta a complicazioni come la paralisi nervo facciale, diminuzione della vista, forti mal di testa, vomito frequente.
La leucemia linfoblastica acuta è imprevedibile: possono esserci sia positivi che conseguenze negative, anche la morte diversi mesi dopo la diagnosi. Il trattamento tempestivo della leucemia linfocitica acuta offre maggiori possibilità di completo sollievo dalla malattia.
Metodi diagnostici
La diagnosi di leucemia linfoblastica acuta viene effettuata sulla base dei segni sintomatici e dei risultati degli studi. L'esame di laboratorio del sangue del paziente rivela livello ridotto emoglobina, trombocitopenia, tasso aumentato La VES e il numero dei leucociti differiscono in molti modi dai valori normali.
I risultati del mielogramma mostrano la presenza di blasti. L’esame del paziente comprende anche:
- studio del liquido cerebrospinale;
- Ultrasuoni della cavità addominale;
- radiografia del torace;
- biochimica del sangue.
Se indicato, può essere eseguita una puntura lombare, soprattutto se il paziente lamenta sintomi caratteristici di un disturbo del sistema nervoso.
Trattamento della malattia
L’obiettivo principale degli operatori sanitari nella leucemia linfoblastica acuta è eliminare le cellule leucemiche. Il trattamento include:
- effettuare la chemioterapia;
- radiazione;
- l'uso della terapia di combinazione, incluso il trapianto di midollo osseo per forme gravi di leucemia linfocitica acuta, quando altri metodi di trattamento non hanno dato risultati positivi.
La chemioterapia per la leucemia linfocitica acuta attraversa diversi periodi:
- La fase iniziale, la profase, prevede un ciclo di chemioterapia. Dura circa una settimana, vengono utilizzati uno o due farmaci citostatici. Durante questo periodo, il trattamento della leucemia linfoblastica acuta mira a ridurre gradualmente i blasti e a preparare il corpo alle seguenti procedure.
- L’induzione è la fase principale durante la quale vengono utilizzati farmaci combinati per massimizzare la distruzione delle cellule tumorali. Di conseguenza, di regola, la leucemia linfoblastica acuta regredisce. Tuttavia, il processo dura circa diversi mesi.
- Il periodo successivo è il consolidamento. Gli specialisti usano altri farmaci per sbarazzarsi della leucemia linfoblastica acuta al fine di consolidare il processo di remissione. Importante qui azioni preventive per prevenire danni al sistema nervoso centrale. Anche in questa fase si può procedere alla distruzione delle cellule leucemiche rimanenti mediante radioterapia.
- Lo stadio finale della leucemia linfoblastica acuta è la terapia di mantenimento. La sua durata è di almeno due anni dall'inizio del trattamento principale.
Se a un neonato viene diagnosticata la leucemia linfoblastica acuta, per il trattamento viene utilizzata l'immunoterapia.
Risultati visibili compaiono circa un mese dopo l'inizio delle misure terapeutiche.
Tutti i metodi per combattere la leucemia linfoblastica acuta sono selezionati individualmente in base alle caratteristiche del corpo. Se un paziente non presenta recidive di leucemia linfocitica acuta entro cinque anni, è considerato completamente guarito.
Monitora la tua salute sottoponendoti a una visita medica annuale, aderendo immagine sana vita e principi di una corretta alimentazione. Ciò contribuirà a prevenire lo sviluppo di malattie gravi e a prolungare la vita.
In contatto con
La leucemia linfoblastica è un tumore maligno che si sviluppa dai precursori dei globuli linfoblastici, inizialmente localizzati nel midollo osseo rosso, e poi metastatizza ai linfonodi, alla milza, al sistema nervoso e ad altri organi interni.
La leucemia linfoblastica presenta le seguenti caratteristiche:
- Tutte le informazioni sul sito sono solo a scopo informativo e NON sono una guida all'azione!
- Solo un MEDICO può darti una DIAGNOSI ACCURATA!
- Vi chiediamo gentilmente di NON automedicare, ma di fissare un appuntamento con uno specialista!
- Salute a te e ai tuoi cari! Non arrenderti
- è il cancro infantile più comune, rappresentandone 1/3 tumore maligno nei bambini;
- rappresenta la stragrande maggioranza di tutti i casi di leucemia acuta nei pazienti di età inferiore a 15 anni (75% delle leucemie acute);
- per ragioni sconosciute, i ragazzi ed i giovani soffrono di questa malattia più spesso delle ragazze in un rapporto di 2:1;
- colpisce più spesso i bambini di età compresa tra 3 e 4 anni;
- molto meno comune negli adulti, il picco di incidenza si verifica in categoria di età 50-60 anni.
Video: sul trattamento della leucemia linfoblastica acuta
Meccanismo di sviluppo
L'ematopoiesi è il processo di formazione degli elementi del sangue formati.
Si parte da una cellula madre, una cellula staminale ematopoietica, che dà vita a 2 tipi di cellule:
- la cellula precursore della linfocitopoiesi, da cui successivamente originano i linfociti;
- la cellula precursore della mielopoiesi, che è l'antenato di eritrociti, leucociti e piastrine.
Il primo tipo funge da antenato delle cellule precursori dei linfociti T e B e formano già le successive giovani cellule immature: i blasti. Nella leucemia linfoblastica, un fallimento nel programma genetico, che porta a una crescita illimitata, può verificarsi in qualsiasi fase della formazione dei linfociti, dalla cellula precursore della linfocitopoiesi alle cellule blastiche.
Pertanto, esistono leucemia linfoblastica a cellule B e T. Se i linfociti già maturi subiscono una degenerazione maligna, questa condizione è chiamata leucemia linfocitica cronica.
Cause
Come ogni cancro, la leucemia linfoblastica si verifica sotto l'influenza non di uno, ma di diversi fattori provocatori.
I più significativi sono:
Radiazione
Il ruolo delle radiazioni ionizzanti nel provocare la degenerazione maligna delle cellule del sangue è stato dimostrato sulla base di un'analisi dei dati su un forte aumento della leucemia tra i residenti delle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, sottoposte a bombardamenti atomici.
Esiste anche evidenza di un aumento dell'incidenza di neoplasie maligne del sangue in pazienti precedentemente sottoposti a radioterapia per il trattamento del cancro.
Sostanze chimiche
Il benzene ha l'effetto oncogeno più forte. Questa è una sostanza ampiamente utilizzata nell'industria. Il benzene è in grado di penetrare nel corpo attraverso la pelle intatta, Vie aeree. Essendo una sostanza liposolubile, si accumula nel tessuto adiposo e nervoso.
Il benzene influenza il tessuto ematopoietico in 2 modi:
- un effetto dannoso diretto in cui la struttura del DNA della cellula ematopoietica viene interrotta;
- un effetto indiretto in cui il materiale genetico viene danneggiato dai prodotti della lavorazione del benzene da parte delle cellule del fegato.
È contenuta una grande quantità di benzene fumo di tabacco, mentre non vengono colpiti solo i fumatori attivi ma anche quelli passivi.
Altre sostanze che possono scatenare lo sviluppo della leucemia sono i pesticidi e altri prodotti chimici utilizzati in agricoltura.
Studi scientifici hanno dimostrato che i genitori che durante la giornata di lavoro entrano in stretto contatto con sostanze contenenti cloro e vernici corrono un rischio maggiore di sviluppare tutti i tipi di leucemia.
È stato inoltre stabilito che la causa della degenerazione maligna del tessuto ematopoietico possono essere i farmaci chemioterapici utilizzati per trattare, ad esempio, la linfogranulomatosi.
Agenti virali
È stato stabilito il ruolo del retrovirus HTLV nello sviluppo della leucemia linfocitica a cellule T. La particella virale contiene geni che, quando interagiscono con materiale genetico cellula emopoietica lo trasforma in cancro.
Anomalie genetiche
La leucemia spesso accompagna malattie ereditarie e anomalie genetiche, come i difetti congeniti del sistema immunitario. La predisposizione ereditaria gioca un ruolo importante nello sviluppo della leucemia linfoblastica. Ciò è stato dimostrato sulla base di uno studio condotto su gemelli il cui fratello o sorella ha sviluppato la leucemia. Allo stesso tempo, il rischio di sviluppare la stessa malattia in un secondo figlio è del 25%.
Sintomi della leucemia linfoblastica
Le manifestazioni della malattia sono molto diverse. In alcuni casi la leucemia linfoblastica non si manifesta per diversi mesi, mentre in altri è caratterizzata da un esordio acuto e violento.
- debolezza;
- sonnolenza;
- aumento della temperatura corporea non associato a una malattia infettiva;
- dolore alle ossa e alle articolazioni.
Molto spesso, i primi segni della malattia sono dolori distanti alle ossa e alla colonna vertebrale.
Poiché i linfonodi nella leucemia linfoblastica acuta si ingrandiscono solo negli stadi molto avanzati della malattia, e anche per il fatto che negli stadi iniziali la formazione di globuli rossi, leucociti e piastrine è leggermente inibita (la loro cellula precursore non è coinvolta nella il processo maligno), la diagnosi può essere stabilita tardi, il che riduce le possibilità di guarigione.
In una piccolissima percentuale di bambini (2%) la prima manifestazione della leucemia linfoblastica è l'anemia aplastica, dovuta alla soppressione della formazione dei globuli rossi durante la proliferazione dei blasti nel midollo osseo rosso. Ciò può anche portare a diagnosi errate.
Nell'1% dei bambini malati si verificano le seguenti manifestazioni di leucemia linfoblastica:
Questi sintomi indicano metastasi precoci dei linfoblasti alle membrane del cervello.
Diagnostica
Quando si esamina un bambino malato, si possono riscontrare pallore, emorragie puntiformi (petecchie), contusioni, aumento della temperatura corporea, dolore alle ossa quando vengono picchiettate e ingrossamento dei linfonodi e della milza.
In caso di leucemia, un esame del sangue rileva i seguenti cambiamenti nei gruppi cellulari:
- leucociti (la norma nei bambini sotto i 3 anni è 6-17 * 109/l): nel 30% dei pazienti si riscontra un numero ridotto di leucociti (leucopenia moderata) pari a 5 * 109/l, ma può raggiungere 1 -2*109/l; nel 13% dei pazienti il contenuto dei leucociti non cambia; i restanti presentano un aumento del numero di leucociti nel sangue (leucocitosi) dovuto alle cellule leucemiche fino a 100*109/l;
- globuli rossi, emoglobina (norma per bambini di età compresa tra 1 e 5 anni g/l): viene rilevata anemia, l'emoglobina scende a 50 g/l;
- blasti: se c'è una diminuzione o importo normale i leucociti, quindi i blasti, di regola, non vengono rilevati; con leucocitosi, è presente nel sangue periferico un gran numero di esplosioni
Quando si diagnostica la leucemia linfoblastica, è obbligatorio eseguire una puntura del midollo osseo rosso, sulla base dei risultati del quale viene compilato un mielogramma, un calcolo dei rapporti dei suoi elementi cellulari. Quando si esamina il midollo osseo rosso, si trova il 30% dei blasti di varie forme, sulla base dei quali viene determinato il tipo specifico di leucemia linfoblastica.
L’esame ecografico rivela un ingrossamento del fegato, della milza e dei linfonodi.
Se i reclami del paziente contengono sintomi di danno al sistema nervoso, allora puntura lombare. Nella neuroleucemia, i blasti vengono rilevati anche nel liquido cerebrospinale. La leucemia T-linfoblastica ha un'immagine radiografica caratteristica: un aumento dell'ombra del mediastino nell'immagine a causa dell'ingrossamento del timo e dei linfonodi intratoracici.
Tutto ciò che riguarda il trattamento della leucemia in Israele è scritto qui.
Trattamento
L’obiettivo principale del trattamento della leucemia linfoblastica è la completa distruzione delle cellule leucemiche.
I trattamenti utilizzati per la leucemia linfoblastica includono:
- chemioterapia (usata in tutti i pazienti);
- radioterapia in combinazione con chemioterapia in pazienti con danno leucemico al sistema nervoso centrale (irradiazione della testa);
- terapia di combinazione con trapianto di midollo osseo nei casi gravi che non sono suscettibili ad altri metodi.
Se il bambino malato non ha bisogno di un trapianto di midollo osseo o il trattamento è stato effettuato senza recidiva (recidiva della malattia), l'intero ciclo di terapia dura circa 2 anni.
La chemioterapia si basa su un protocollo, uno schema standardizzato per l'uso di determinati farmaci, che differisce a seconda del vari tipi leucemia linfoblastica.
Ogni protocollo di trattamento è composto dai seguenti passaggi:
- Profase.
- Induzione.
- Consolidamento e terapia intensiva.
- Reinduzione.
- Terapia di mantenimento.
Profase
Si tratta di un trattamento preparatorio che prevede un breve ciclo di chemioterapia (circa 1 settimana) utilizzando 1-2 farmaci citotossici. Questa fase è necessaria per iniziare una graduale diminuzione del numero di blasti.
Induzione
Palco principale. Implica la chemioterapia intensiva con una combinazione di farmaci. Il suo obiettivo è ottenere la massima distruzione possibile delle cellule leucemiche in breve tempo. Il risultato dell’induzione è la remissione, cioè la “recessione della malattia”. La durata del corso è di 1,5-2 mesi.
Consolidamento
In questa fase, viene utilizzata una combinazione di nuovi farmaci citostatici per consolidare la remissione e viene effettuata la prevenzione del danno al sistema nervoso centrale. Ad alcuni pazienti viene prescritta la radioterapia sotto forma di irradiazione alla testa. Durata fino a 1 mese.
Reinduzione
Questa fase assomiglia alla fase di induzione. Il suo scopo è distruggere le cellule leucemiche rimanenti nel corpo. Dura da diverse settimane a diversi mesi.
Terapia di mantenimento
Viene eseguito in regime ambulatoriale con basse dosi di citostatici. Continuare fino a quando non siano trascorsi 2 anni esatti dall'inizio del trattamento.
I sintomi della leucemia nei bambini sono descritti in questo articolo.
Foto della leucemia linfoblastica acuta qui.
Previsione
La prognosi per la leucemia linfoblastica si basa sul tempo durante il quale il paziente vivrà senza ricadute dopo un ciclo completo di trattamento. La sopravvivenza libera da malattia a cinque anni è stata presa come standard. Se entro 5 anni dal completamento del trattamento non si verifica una ricaduta della malattia, il paziente è considerato guarito.
La leucemia linfoblastica nei bambini è facilmente curabile utilizzando protocolli moderni; il tasso di sopravvivenza senza recidive a cinque anni è del 90%.
I seguenti fattori influenzano la previsione:
- livello di leucociti nel sangue al momento della diagnosi;
- età del paziente;
- la recidiva si verifica durante il trattamento o dopo poco tempo dopo di lui.
Maggiore è il numero dei globuli bianchi al momento della diagnosi, peggiore è la prognosi.
Il tasso di sopravvivenza dei bambini di età compresa tra 2 e 6 anni è 1,5 volte più lungo rispetto a quello dei pazienti di età superiore a 6 anni e inferiore a 2 anni.
La prognosi per i neonati affetti da leucemia linfoblastica è molto spesso sfavorevole. Nella vecchiaia, il recupero si osserva nel 55% dei casi.
- Evgeniy su Esame del sangue per le cellule tumorali
- Marina sul trattamento del sarcoma in Israele
- Nadezhda su Leucemia acuta
- Galina sul trattamento del cancro ai polmoni con rimedi popolari
- chirurgo maxillo-facciale e plastico per la registrazione dell'Osteoma del seno frontale
Le informazioni sul sito sono fornite esclusivamente per scopi informativi divulgativi, non pretendono di essere riferimenti o accuratezza medica e non costituiscono una guida all'azione.
Non automedicare. Consulta il tuo medico.
Leucemia linfoblastica acuta
La leucemia linfoblastica acuta è una lesione maligna del sistema emopoietico, accompagnata da un aumento incontrollato del numero di linfoblasti. Manifestato da anemia, sintomi di intossicazione, ingrossamento dei linfonodi, del fegato e della milza, aumento del sanguinamento e disturbi respiratori. A causa della ridotta immunità nella leucemia linfoblastica acuta, spesso si sviluppano malattie infettive. Possibili danni al sistema nervoso centrale. La diagnosi viene effettuata sulla base dei sintomi clinici e dei dati di laboratorio. Trattamento – chemioterapia, radioterapia, trapianto di midollo osseo.
Leucemia linfoblastica acuta
La leucemia linfoblastica acuta (LLA) è il tumore infantile più comune. La quota di ALL rappresenta il 75-80% del numero totale di casi di malattie del sistema ematopoietico nei bambini. Il picco di incidenza si verifica tra 1 e 6 anni. I ragazzi sono colpiti più spesso delle ragazze. I pazienti adulti si ammalano 8-10 volte meno spesso dei bambini. Nei pazienti pediatrici, la leucemia linfoblastica acuta si manifesta principalmente; negli adulti, è spesso una complicazione della leucemia linfocitica cronica. Nelle sue manifestazioni cliniche, la LLA è simile ad altre leucemie acute. Una caratteristica distintiva è il danno più frequente alle membrane del cervello e del midollo spinale (neuroleucemia), che, in assenza di prevenzione, si sviluppa nel 30-50% dei pazienti. Il trattamento viene effettuato da specialisti nel campo dell'oncologia e dell'ematologia.
Secondo la classificazione dell’OMS, esistono quattro tipi di LLA: cellule pre-pre-B, cellule pre-B, cellule B e cellule T. Le leucemie linfoblastiche acute a cellule B rappresentano l'80-85% del numero totale dei casi. Il primo picco di incidenza si verifica all’età di 3 anni. Successivamente, la probabilità di sviluppare la LLA aumenta dopo i 60 anni di età. La leucemia a cellule T rappresenta il 15-20% del numero totale di casi della malattia. Il picco di incidenza si verifica all’età di 15 anni.
Cause della leucemia linfoblastica acuta
La causa immediata della leucemia linfoblastica acuta è la formazione di un clone maligno, un gruppo di cellule con la capacità di riprodursi in modo incontrollabile. Un clone si forma a seguito di aberrazioni cromosomiche: traslocazione (scambio di sezioni tra due cromosomi), delezione (perdita di una sezione di un cromosoma), inversione (inversione di una sezione di un cromosoma) o amplificazione (formazione di copie aggiuntive di una sezione di un cromosoma). Si presume che disturbi genetici, causando sviluppo leucemia linfoblastica acuta, insorgono nel periodo prenatale, tuttavia, sono spesso necessarie ulteriori circostanze esterne per completare il processo di formazione di un clone maligno.
Tra i fattori di rischio per lo sviluppo della leucemia linfoblastica acuta, l'esposizione alle radiazioni è solitamente indicata principalmente: vita in un'area con un aumento del livello di radiazioni ionizzanti, radioterapia nel trattamento di altre malattie oncologiche, numerosi studi a raggi X, anche nel periodo prenatale periodo. Il livello di associazione, così come l’evidenza di una relazione, tra varie esposizioni alle radiazioni e lo sviluppo della leucemia linfoblastica acuta varia notevolmente.
Consulenza legale gratuita:
Pertanto, la relazione tra leucemia e radioterapia è ormai considerata provata. Il rischio di sviluppare leucemia linfoblastica acuta dopo la radioterapia è del 10%. Nell'85% dei pazienti la malattia viene diagnosticata entro 10 anni dal completamento della radioterapia. Connessione tra Esami radiografici e lo sviluppo della leucemia linfoblastica acuta rimane attualmente a livello di speculazione. Dati statistici affidabili che confermino questa teoria non esistono ancora.
Molti ricercatori sottolineano una possibile connessione tra LLA e le malattie infettive. Il virus che causa la leucemia linfoblastica acuta non è stato ancora identificato. Ci sono due ipotesi principali. La prima è che la LLA è causata da un unico virus non ancora identificato, ma la malattia si manifesta solo in presenza di una predisposizione. La seconda è che lo sviluppo della leucemia linfoblastica acuta può essere causato da diversi virus; il rischio di sviluppare la leucemia nei bambini aumenta con la mancanza di contatto con microrganismi patogeni in gioventù(se il sistema immunitario è “non allenato”). Finora entrambe le ipotesi non sono state dimostrate. Informazioni affidabili sull'esistenza di una connessione tra leucemia e malattie virali ottenuto solo per la leucemia a cellule T in pazienti adulti che vivono nei paesi asiatici.
La probabilità di sviluppare leucemia linfoblastica acuta aumenta con il contatto materno con alcune sostanze tossiche durante la gestazione, con alcune anomalie genetiche (anemia di Fanconi, sindrome di Down, sindrome di Shwachman, sindrome di Klinefelter, sindrome di Wiskott-Aldrich, neurofibromatosi, malattia celiaca, disturbi immunitari ereditari), la presenza di storia familiare di cancro e l'assunzione di citostatici. Alcuni esperti notano i possibili effetti negativi del fumo.
Sintomi della leucemia linfoblastica acuta
La malattia si sviluppa rapidamente. Al momento della diagnosi, la massa totale dei linfoblasti nel corpo può rappresentare il 3-4% del peso corporeo totale, a causa della rapida proliferazione delle cellule del clone maligno negli ultimi 1-3 mesi. Entro una settimana, il numero di cellule raddoppia circa. Esistono diverse sindromi caratteristiche della leucemia linfoblastica acuta: intossicazione, iperplastica, anemica, emorragica, infettiva.
La sindrome da intossicazione comprende debolezza, affaticamento, febbre e perdita di peso. Un aumento della temperatura può essere provocato sia dalla malattia di base che dalle complicanze infettive, che si sviluppano soprattutto spesso in presenza di neutropenia. La sindrome iperplastica nella leucemia linfoblastica acuta si manifesta con l'ingrossamento dei linfonodi, del fegato e della milza (a seguito dell'infiltrazione leucemica del parenchima dell'organo). Con l'allargamento degli organi parenchimali può comparire dolore addominale. Un aumento del volume del midollo osseo, l'infiltrazione del periostio e dei tessuti delle capsule articolari possono causare dolori osteoarticolari dolorosi.
La presenza della sindrome anemica è indicata da debolezza, vertigini, pallore e aumento della frequenza cardiaca. La causa dello sviluppo della sindrome emorragica nella leucemia linfoblastica acuta è la trombocitopenia e la trombosi piccoli vasi. Petecchie ed ecchimosi si riscontrano sulla pelle e sulle mucose. Con i lividi si verificano facilmente estese emorragie sottocutanee. Si osserva un aumento del sanguinamento da ferite e graffi, emorragie retiniche, gengivali e sangue dal naso. Alcuni pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta presentano sanguinamento gastrointestinale, accompagnato da vomito con sangue e feci catramose.
I disturbi immunitari nella leucemia linfoblastica acuta si manifestano con frequenti infezioni di ferite, graffi e segni di puntura. Possono svilupparsi varie infezioni batteriche, virali e fungine. Con l'ingrossamento dei linfonodi mediastinici, si osservano disturbi respiratori dovuti alla diminuzione del volume polmonare. L'insufficienza respiratoria è più comune nella leucemia linfoblastica acuta a cellule T. La neuroleucemia, provocata dall'infiltrazione delle membrane del midollo spinale e del cervello, è più spesso osservata durante le ricadute.
Quando è coinvolto il sistema nervoso centrale, positivo sintomi meningei e segni di aumento della pressione intracranica (papilledema, mal di testa, nausea e vomito). A volte il danno al sistema nervoso centrale nella leucemia linfoblastica acuta è asintomatico e viene diagnosticato solo dopo l'esame del liquido cerebrospinale. Nel 5-30% dei ragazzi compaiono infiltrati nei testicoli. Nei pazienti di entrambi i sessi possono comparire infiltrati violacei-bluastri (leucemidi) sulla pelle e sulle mucose. In rari casi si osserva versamento di pericardite e disfunzione renale. Sono stati descritti casi di lesioni intestinali.
Tenendo conto delle caratteristiche dei sintomi clinici, si possono distinguere quattro periodi di sviluppo della leucemia linfoblastica acuta: iniziale, picco, remissione, terminale. La durata del periodo iniziale è di 1-3 mesi. Predominano i sintomi aspecifici: letargia, affaticamento, perdita di appetito, febbricola e crescente pallore della pelle. Sono possibili mal di testa, dolori all'addome, alle ossa e alle articolazioni. Durante il culmine della leucemia linfoblastica acuta, vengono rilevate tutte le sindromi caratteristiche di cui sopra. Durante il periodo di remissione, le manifestazioni della malattia scompaiono. Il periodo terminale è caratterizzato da un progressivo deterioramento delle condizioni del paziente e termina con la morte.
Diagnosi di leucemia linfoblastica acuta
La diagnosi viene fatta tenendo conto dei segni clinici, dei risultati degli esami del sangue periferico e dei dati del mielogramma. Nel sangue periferico di pazienti con leucemia linfoblastica acuta si rilevano anemia, trombocitopenia, aumento della VES e cambiamenti nel numero dei leucociti (solitamente leucocitosi). I linfoblasti costituiscono più dell'1% del numero totale di leucociti. Il numero di neutrofili è ridotto. Nel mielogramma predominano le cellule blastiche e viene determinata una pronunciata inibizione della linea eritroide, neutrofila e piastrinica.
Il programma di esame per la leucemia linfoblastica acuta comprende la puntura lombare (per escludere la neuroleucemia), l'ecografia degli organi addominali (per valutare le condizioni degli organi parenchimali e dei linfonodi), la radiografia del torace (per rilevare i linfonodi mediastinici ingrossati) e un esame del sangue biochimico ( per identificare disfunzioni). fegato e reni). La diagnosi differenziale della leucemia linfoblastica acuta viene effettuata con altre leucemie, avvelenamenti, condizioni di gravi malattie infettive, linfocitosi infettiva e mononucleosi infettiva.
Trattamento e prognosi della leucemia linfoblastica acuta
La base della terapia è la chemioterapia. Esistono due fasi di trattamento per TUTTI: fase terapia intensiva e la fase di terapia di mantenimento. La fase di terapia intensiva per la leucemia linfoblastica acuta comprende due fasi e dura circa sei mesi. Nella prima fase viene eseguita la chemioterapia endovenosa per ottenere la remissione. Lo stato di remissione è indicato dalla normalizzazione dell'ematopoiesi, dalla presenza di non più del 5% di blasti nel midollo osseo e dall'assenza di blasti nel sangue periferico. Nella seconda fase vengono adottate misure per prolungare la remissione, rallentare o arrestare la proliferazione delle cellule del clone maligno. I farmaci vengono somministrati anche per via endovenosa.
La durata della fase di terapia di mantenimento per la leucemia linfoblastica acuta è di circa 2 anni. Durante questo periodo il paziente viene dimesso trattamento ambulatoriale, prescrivere farmaci per via orale ed effettuare esami regolari per monitorare le condizioni del midollo osseo e del sangue periferico. Il piano di trattamento per la leucemia linfoblastica acuta viene redatto individualmente, tenendo conto del livello di rischio in un particolare paziente. Insieme alla chemioterapia, vengono utilizzate l'immunoterapia, la radioterapia e altre tecniche. Con bassa efficacia del trattamento e alto rischio sviluppo di recidive, viene eseguito il trapianto di midollo osseo. Il tasso medio di sopravvivenza a cinque anni per la leucemia linfoblastica acuta a cellule B nell’infanzia è dell’80-85%, negli adulti del 35-40%. Con la leucemia T-linfoblastica, la prognosi è meno favorevole.
Leucemia linfoblastica acuta - trattamento a Mosca
Elenco delle malattie
Malattie oncologiche
Ultime novità
- © 2018 “Bellezza e Medicina”
solo a scopo informativo
e non sostituisce l'assistenza medica qualificata.
Leucemia linfoblastica
La forma linfoblastica della leucemia è una malattia associata a disfunzione sistema circolatorio, è maligno, più spesso riscontrato nei bambini. Esistono diversi tipi di malattie. Si tratta di leucemia linfoblastica acuta e cronica. Analizziamo questi patologi più in dettaglio.
Tipi di leucemia
Forma acuta della malattia
La leucemia linfoblastica acuta può svilupparsi a causa di una violazione di due tipi di linfociti: B o T. Ciò è dovuto a una disfunzione del gruppo di cellule corrispondente. Le cellule non granulari comprendono i leucociti dei gruppi B e T, che subiscono diverse fasi di differenziazione durante lo sviluppo. La prima fase presentata è esplosiva. Per una serie di ragioni, il midollo osseo interrompe le funzioni di formazione e maturazione dei leucociti. Più spesso questa causa è una formazione tumorale maligna. Nella leucemia linfoblastica acuta, il gruppo B è più spesso colpito: nell'89% dei casi. Questi leucociti sono responsabili della formazione di anticorpi nel corpo umano, motivo per cui tale malattia è così grave.
La leucemia linfoblastica acuta si verifica con la manifestazione di intossicazione del corpo, cioè la temperatura aumenta, iniziano i disturbi nel funzionamento degli organi interni, il dolore severo e le patologie del sistema nervoso. Tutto ciò è accompagnato da una progressiva perdita di peso.
La leucemia linfoblastica acuta colpisce più bambini e adolescenti ed è accompagnata da danni ad organi come la milza, timo, Midollo osseo, sistema linfatico, altri organi altrettanto importanti.
Cause della malattia
La leucemia linfoblastica acuta si verifica a causa di cambiamenti genetici nella struttura dei cromosomi. La malattia è accompagnata dall'identificazione di alcune aberrazioni: cromosomiche non specifiche, specifiche o primarie. Il motivo per cui viene diagnosticata la leucemia linfoblastica acuta è la presenza di disturbi primari come cellule oncogene, geni dei fattori di crescita o inversioni e traslocazioni dei cromosomi.
La medicina non ha ancora determinato l'unica causa che provoca la malattia, ma vengono identificati anche diversi fattori di rischio. Di questi si possono individuare i principali: predisposizione genetica, malattia congenita, effetti avversi sul feto radiazione a raggi X, malattie come la sindrome di Down. È stato anche rivelato un modello secondo cui la popolazione dalla pelle bianca ha maggiori probabilità di soccombere a questa malattia.
Sintomi della malattia
I sintomi del decorso acuto della malattia possono essere identificati come segue:
- aumento della temperatura corporea in un contesto di malessere generale;
- stanchezza rapida e senza causa;
- forte dolore costante ossa, grandi articolazioni;
- le malattie infettive si verificano spesso sullo sfondo della malattia;
- la pelle perde colore e diventa pallida;
- appare un'eruzione emorragica, frequente, piccola;
- i linfonodi sono leggermente gonfi e dolorosi;
- il dolore viene dalla milza, dal fegato.
Il quadro sintomatico generale e i sintomi individuali compaiono a seconda del numero di cellule patologicamente alterate che circolano nel corpo del paziente. Esiste anche una connessione diretta tra i sintomi e la posizione del focus patologico. Il numero di leucociti diminuisce, il che porta a reddito insufficiente ossigeno alle cellule. I processi metabolici a livello cellulare vengono interrotti e compaiono sintomi di deviazioni nei processi metabolici generali del corpo del paziente.
In medicina, questa condizione è definita anemia, quando si osserva una diminuzione del numero dei globuli rossi, in questo contesto la pelle diventa pallida, debolezza generale, l'appetito diminuisce, inizia una rapida perdita di peso e altre malattie comuni.
Quando le cellule patologicamente alterate trovano una posizione come gli organi del sistema nervoso - il cervello o il midollo spinale, il funzionamento del sistema nervoso può essere interrotto, possono comparire mal di testa e vomito frequente. Ma questi sintomi sono estremamente rari e non sono affidabili quando esame diagnostico malato.
Inoltre, patologicamente, le cellule possono colpire i testicoli, causando gonfiore e forte dolore.
Misure diagnostiche
Per diagnosticare e selezionare un protocollo di trattamento, vengono eseguite una serie di misure volte a identificare il focus patologico, la sua natura, la posizione e la negligenza del processo. Vengono presi in considerazione la composizione delle cellule modificate, i dati di laboratorio e radiologici e vengono anche raccolti l'anamnesi e il quadro sintomatico.
La diagnosi viene effettuata sulla base di un complesso di sindromi patologiche:
- intossicazione - manifestata da debolezza in tutto il corpo, perdita di peso, febbre prolungata, che è direttamente associata a una malattia infettiva batterica, virale, fungina o protozoaria;
- anemico - si manifesta a causa di una carenza nella produzione di globuli rossi nel midollo osseo, appare pallore, sanguinamento senza causa in bocca, debolezza, disfunzione cardiaca - tachicardia e manifestazioni emorragiche sulla pelle;
- iperplastico - si verifica spesso nel caso di una diagnosi di leucemia non linfoblastica, ma più spesso accompagna un decorso più acuto di patologia di natura linfoblastica e si manifesta con un aumento significativo di tutti i gruppi di linfonodi, sia distanti che regionali, inoltre, uno specialista palpa un doloroso ispessimento dei nodi. Tutto ciò è accompagnato da sensazioni dolorose nella cavità addominale, cambiamenti patologici nel tessuto osseo, in particolare nella colonna vertebrale, il dolore in cui si manifesta poco dopo la malattia stessa;
- emorragico - una manifestazione diretta di trombocitopenia e trombosi, che porta a manifestazioni sulla pelle sotto forma di petecchie e melena, emorragie minori e sanguinamento senza causa dalla mucosa orale.
Il complesso delle sindromi può differire nelle ragazze e nei ragazzi. Quindi, in questi ultimi, è possibile una diminuzione delle dimensioni dei testicoli, fino al 35% del volume. Potrebbe esserci un ingrossamento dei reni e di altri organi vitali a causa dell'eccessiva infiltrazione dei tessuti, ma qualsiasi manifestazione di tali cambiamenti può essere completamente assente.
Nell’anamnesi, questa diagnosi è prescritta come “leucemia linfoblastica acuta (cronica)” n – opzione, t – periodo acuto. Potrebbero essere indicati diversi periodi nella storia, nonché opzioni.
L'anamnesi di tutti i pazienti indica un trattamento: chemioterapia intensiva, che indica la gravità e l'importanza del problema terapeutico, fino all'intervento chirurgico e alla chemioterapia più potente.
Trattamento della malattia
In totale, ci sono 7 protocolli secondo i quali viene effettuato il trattamento di persone con patologie del sangue oncologiche. Recentemente, il trattamento dei pazienti con alterazioni patologiche del sangue viene effettuato secondo un protocollo basato sul principio del trattamento con polichemioterapia intensiva.
L'obiettivo del trattamento specificato in questo protocollo può essere determinato dalla distruzione del numero massimo di focolai del processo patologico nelle cellule del sangue.
Le fasi specificate nel protocollo moderno sono:
- induzione della remissione;
- consolidamento della remissione;
- trattamento di supporto.
L'induzione della remissione della malattia viene effettuata utilizzando diversi agenti, che vengono somministrati nell'arco di diverse settimane specificate nel protocollo. La seconda fase del protocollo consiste in un effetto multi-agente sul fattore patologico. E, di conseguenza, viene eseguita la terza fase del protocollo: il trattamento di mantenimento per continuare la remissione della malattia.
Decorso cronico
globuli bianchi
Il processo patologico, già entrato nella fase cronica, è elencato nel protocollo come “Leucemia linfoide cronica” e richiede un intervento terapeutico appropriato.
Per quanto riguarda la diagnostica questo processo, quindi misure come esame del sangue generale, biopsia, diagnostica ecografica della cavità addominale e puntura del midollo osseo. Inoltre, come misure aggiuntive, possono essere eseguite punture del midollo spinale e una biopsia dell'area infiammatoria direttamente nel luogo dell'epidemia.
La diagnosi finale viene effettuata sulla base di un esame del sangue e di un esame da parte di un ematologo. Anche con un decorso non standard del processo patologico, sono necessarie molte forature aggiuntive delle aree interessate e delle aree distanti dalla fonte.
Nel caso in cui sullo sfondo della leucemia si verifichino altre complicazioni sistemiche di natura autoimmune, la diagnosi diventa più complicata, iniziano a produrre e ad agire proteine aggressive che hanno un effetto distruttivo sulle cellule normali e ancora sane.
Tali complicazioni autoimmuni si verificano abbastanza spesso, in oltre il 35% dei casi. Altri concomitanti negativi del cancro del sangue possono essere lesioni infettive di natura infiammatoria o non infiammatoria - raffreddori tipici, febbre, patologie virali, infezioni che colpiscono il sistema genito-urinario.
Col progredire, la forma cronica diventa maligna e termina con la morte nel 30-40% dei casi.
Sintomi
Il tipico quadro sintomatico che compare nei pazienti affetti da leucemia cronica è lieve ed è accompagnato dai seguenti segni:
- progressiva perdita di peso corporeo;
- è aumentato debolezza senza causa per tutto il corpo;
- sensazione di pesantezza allo stomaco;
- aumento della sudorazione, alterazione della termoregolazione nel corpo;
- i linfonodi sono ingrossati e dolorosi;
- c'è una tendenza alle malattie infettive.
Il primo segno di manifestazione forma cronica, possiamo evidenziare la comparsa di linfonodi ingrossati. Anche la milza si ingrandisce, creando una sensazione di pesantezza nella cavità addominale. Possono verificarsi anche sensazioni dolorose e la capacità di eseguire prestazioni può essere persa. attività fisica, perde gradualmente peso, diminuisce l'appetito, la persona diventa depressa e richiede un trattamento immediato.
Trattamento della forma cronica
Il processo cronico secondo il protocollo richiede trattamento chemioterapico, esposizione alle radiazioni, bioimmunoterapia e altri. Diamo uno sguardo più da vicino.
Trattamento chemioterapico per il dotto malato decorso cronico risponde al farmaco "Chlorbutina". Ma l'anno scorso La medicina concentra sempre più i suoi sforzi sul miglioramento terapia farmacologica, ecco perché un altro farmaco ha guadagnato popolarità, questo è un analogo purinico di "Fludar".
Bioimmunoterapia per patologia cronica consiste nell’utilizzo di anticorpi monoclonali. Presentando farmaci simili riesce ad avere un effetto distruttivo su cellule patologiche sangue. Inoltre, questo è un metodo delicato: le cellule del sangue sane sotto l'influenza dei farmaci più potenti non vengono influenzate, continuando a svolgere la loro funzione fisiologica.
Ricaduta
Una forma lieve di patologia del sangue è la leucemia acuta non linfoblastica, che è piuttosto rara e il rischio di recidiva è minimo. Ma quando si tratta di lesioni linfoblastiche, ci sono molti fattori che provocano la recidiva. In quali casi può verificarsi una ripetizione (recidiva) di un processo patologico nel sangue?
La sede più comune delle recidive è il midollo osseo, è in questo organo che la patologia si ripresenta ed è più pericolosa.
Il sistema nervoso centrale può anche essere la sede di patologie ricorrenti. In questo caso è necessario trattare immediatamente la lesione con Methotrex fino alla completa scomparsa del quadro sintomatico della recidiva.
Nonostante la maggior parte dei pazienti siano bambini, la malattia può colpire chiunque. La presenza di fattori di rischio, predisposizione, ecc. è importante. Ma l'esito del trattamento dipende da fattori quali l'età, il funzionamento del sistema nervoso, la presenza del cromosoma T, vecchiaia e tempestivo inizio del trattamento.