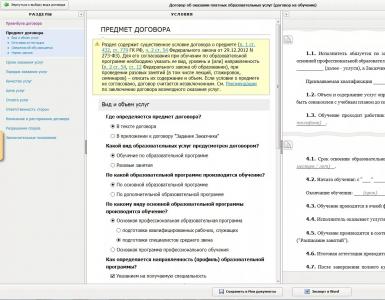Trattamento dell'anemia emolitica. Anemia emolitica: che cos'è? Cause di anemia da carenza di vitamina B12 nei bambini
Le malattie del sangue sono una delle più comuni, spesso sono accompagnate da altre malattie concomitanti e sono molto pericolose per la vita umana. Tra queste malattie spicca l'anemia emolitica. Cos'è? In parole semplici Non è facile da spiegare, ma ci proveremo.
Cos'è l'anemia emolitica?
Prima di iniziare la storia dell'anemia emolitica, approfondiamo un po' l'anatomia e analizziamo il processo di formazione del sangue nel suo insieme. Come tutti sanno dai corsi scolastici, ruolo importante I globuli rossi svolgono un ruolo nel nostro corpo: i globuli rossi, fornendo ossigeno a tutti i tessuti. Il midollo osseo umano è responsabile della formazione dei globuli rossi e la milza è responsabile della loro distruzione.
In media, il ciclo di vita dei globuli rossi è di circa 100 – 120 giorni, ovvero circa quattro mesi. Il midollo osseo e la milza lavorano simultaneamente per produrre e distruggere i globuli rossi. Inoltre, se questi due organi lavorano allo stesso ritmo, l'equilibrio nel corpo viene mantenuto e il sangue viene rinnovato regolarmente. Ma se per qualche motivo la distruzione dei globuli rossi avviene a un ritmo accelerato e il midollo osseo non riesce a farcela e non ha il tempo di formare nuove cellule, allora si verifica uno squilibrio e compaiono i presupposti per l'anemia emolitica, che può poi svilupparsi in forme molto complesse.
Questo processo accelerato di distruzione dei globuli rossi è chiamato emolisi, da cui il nome della malattia. È molto pericoloso e richiede diagnosi tempestiva e un trattamento adeguato.
Classificazione delle anemie emolitiche
 Anemia emoliticaè il nome generico di una serie di malattie causate dalla distruzione accelerata e anormale dei globuli rossi. Queste stesse malattie possono essere classificate in base a una serie di caratteristiche.
Anemia emoliticaè il nome generico di una serie di malattie causate dalla distruzione accelerata e anormale dei globuli rossi. Queste stesse malattie possono essere classificate in base a una serie di caratteristiche.
In base alla natura del fattore causale si distinguono:
Tipi ereditari di anemia:
- Nespherocytaria: in questo caso, la malattia è colpa degli enzimi responsabili della vitalità dei globuli rossi. Più precisamente, la loro assenza. Fondamentalmente c'è una carenza di un enzima come la glucosio-6-fosfato deidrogenasi.
- Anemia di Minkowski-Choffard: con questo nome i medici comprendono una malattia del sangue che si verifica a seguito della mutazione dei geni responsabili della formazione delle proteine e delle proteine necessarie. In questo caso, la membrana dei globuli rossi viene distrutta. Il ciclo di vita, di conseguenza, è notevolmente ridotto.
- Talassemia: il punto qui è l'incapacità di formare emoglobina normale. Si verifica un'ossidazione prematura e, di conseguenza, un danno alla membrana eritrocitaria.
- Anemia falciforme: i globuli rossi acquisiscono una insolita forma a falce, che interferisce con il loro libero passaggio attraverso i vasi. Perchè hanno questa forma? Durante la sintesi dell'emoglobina, la sequenza degli aminoacidi viene interrotta e la forma dell'emoglobina viene deformata, seguita dalle cellule del sangue.
Anemia emolitica acquisita:
- Anemia dei neonati dovuta al conflitto Rh: se la madre ha un fattore sanguigno Rh negativo, potrebbe sorgere un conflitto tra il suo sangue e il sangue del feto e si verificherà il rigetto. Questa incompatibilità fa sì che il corpo della madre produca anticorpi. In risposta a ciò, il corpo del feto produce complessi immunitari, capace di distruggere i globuli rossi.
- Anemia autoimmune: quando i globuli rossi vengono distrutti, si formano anticorpi ostili ai macrofagi, noti difensori dell'organismo. Il sistema immunitario si attiva e inizia a distruggere tali cellule a un ritmo accelerato.
- Sotto l'influenza di qualsiasi esterno o fattori interni– L’anemia può svilupparsi sotto l’influenza di vari medicinali, entrati nel corpo, veleni industriali e organici trasferiti malattie virali e dopo gravi malattie infettive.
- Anemia emolitica traumatica: può verificarsi se nel corpo vengono impiantati vasi sanguigni artificiali o valvole cardiache.
- Emoglobinuria parossistica notturna acuta: questo tipo di anemia è piuttosto raro ed è causato dalla comparsa di difetti nelle membrane dei globuli rossi, che si formano sotto l'influenza delle proteine.
- Danni chimici ai globuli rossi: possono verificarsi sotto l'influenza di pesticidi, benzene, piombo, ecc.
A seconda della sede dell’emolisi, l’anemia si divide in:
- Intravascolare: le cellule vengono distrutte all'interno dei vasi principalmente a causa dell'impatto meccanico su di essi.
- Intracellulare: la distruzione avviene nella milza o nel fegato.
Cause dell'anemia
Per capire come trattare l'anemia emolitica e in quale direzione muoversi, è necessario conoscere i motivi principali per cui questa malattia può comparire in primo luogo e complicarsi notevolmente la vita.
Quindi, i motivi principali includono:
- Anomalie genetiche e difetti congeniti;
- Malattie dei vasi sanguigni e dei tessuti connettivi - reumatismi, artrosi, lupus eritematoso, sclerodermia, vasculite, ecc.);
- Malattie del sangue – leucemia;
- Infezioni batteriche e virali;
- Lavorare con tossine e veleni industriali;
- Trattamento con antibiotici, vari farmaci antinfiammatori;
- Ustioni, lesioni gravi o interventi chirurgici nel corpo;
- Malattia cardiaca congenita, nonché infiammazione del suo strato interno o delle valvole;
- Conflitto Rh in gravidanza.
Come capisci, l'anemia emolitica stessa appare come una malattia separata solo nel caso di prerequisiti congeniti per questo o con scarsa ereditarietà. Fondamentalmente, è una malattia concomitante o secondaria sullo sfondo di altre malattie, nonché una conseguenza di lesioni precedenti.
Metodi per diagnosticare l'anemia emolitica
 Per confermare se hai davvero l'anemia emolitica, viene effettuata una diagnosi, prescritta prima da un terapista e poi da specialisti competenti, a seconda della natura della malattia.
Per confermare se hai davvero l'anemia emolitica, viene effettuata una diagnosi, prescritta prima da un terapista e poi da specialisti competenti, a seconda della natura della malattia.
Prima di tutto, al paziente viene necessariamente prescritto un esame del sangue generale, che può determinare con precisione il livello di concentrazione di emoglobina nel sangue, il numero di globuli rossi, la presenza di globuli rossi, nonché le loro forme immature - reticolociti e il tasso di VES.
Se questa analisi generale mostra il sospetto di emolisi, allora tipi aggiuntivi diagnostica come:
- Analisi del sangue biochimica per determinare la concentrazione di bilirubina;
- Uno studio per confermare la presenza di emolisi nel paziente;
- Analisi delle urine per determinare la presenza di urobilina ed emoglobina in essa;
- foratura midollo osseo. La procedura non è piacevole, ma in alcuni casi potrebbe essere l'unica procedura che confermerà la presenza di questa malattia.
Come si manifesta la malattia?
Poiché le malattie del sangue sono molto pericolose, non dovresti aspettare che la tua salute peggiori completamente. Dovresti assolutamente consultare un medico se noti uno dei seguenti sintomi:
- L'urina è diventata scura, marrone o quasi nera.
- C'è un notevole allentamento delle feci.
- Senza una ragione apparente, la temperatura corporea aumenta.
- La pelle, la sclera e le mucose esterne acquisiscono una tinta giallastra.
- Spesso si verificano vertigini, debolezza generale, mancanza di respiro e aumento della frequenza cardiaca.
- Dolore e pesantezza nell'ipocondrio destro, nella zona del fegato.
- Dolore Petto, così come nello stomaco e nelle ossa.
Uno qualsiasi di questi segni dovrebbe allertarvi e indurre ad una visita immediata dal medico, che, se viene diagnosticata un'anemia emolitica, darà il suo parere linee guida cliniche.
Tipi di anemia emolitica e metodi di trattamento
I metodi di trattamento per l'anemia emolitica sono prescritti esclusivamente da un medico; dipendono dal tipo specifico di malattia e dallo stadio di abbandono.
Diamo un'occhiata ad alcuni di loro.
- Talassemia. Questa non è nemmeno una malattia, ma l'intero gruppo che viene ereditato. In questo caso, si osservano anomalie congenite nel bambino: labbro leporino, cranio a torre, ecc. forte aumento dimensione della milza. Quando si esegue un esame del sangue, si osserva un livello elevato di ferro e anche di bilirubina. Poiché la malattia è ereditaria, viene trattata principalmente durante i periodi di esacerbazione prescrivendo al paziente acido folico e trasfusione di globuli rossi concentrati. Se la malattia è accompagnata da un significativo ingrossamento della milza, viene rimossa chirurgicamente.
- Malattia di Minkowski-Choffard (microsferocitosi). È anche malattia ereditaria. Quando ciò avviene, gli ioni sodio entrano nei globuli rossi attraverso disturbi nella membrana. Le prime manifestazioni di questa malattia sono visibili durante l'infanzia o adolescenza. In questo caso, il bambino può avere deviazioni esterne come denti irregolari, lobo dell'orecchio attaccato, un cranio a torre e una forte inclinazione degli occhi. Inoltre si può osservare ingiallimento della pelle e ingrossamento della milza. Quando è presente questo tipo di anemia emolitica, un esame del sangue di solito mostra un'anemia microcitica o iperrigenerativa. Nelle forme lievi, questa malattia di solito non viene trattata, ma nei casi più gravi viene eseguita una splenectomia: la milza viene rimossa.
- Malattia emolitica dei neonati causata dal conflitto Rh con il sangue della madre. Quando lo diagnostichi, devi farlo obbligatorio escludere l'anemia congenita trasmessa geneticamente.
- La porfiria è un altro tipo di anemia emolitica. Di norma, questa malattia si manifesta principalmente nei ragazzi ed è associata a una violazione della sintesi del pigmento naturale nell'emoglobina: la porfirina. Con questa malattia si verifica un aumento del processo di deposizione del ferro organi diversi e tessuti. Può depositarsi nel pancreas, che è un prerequisito per lo sviluppo del diabete, nel fegato, e poi si ingrandisce notevolmente, o nella pelle, dopo di che acquisisce una tonalità scura. La malattia viene trattata con un'infusione di globuli rossi concentrati e vengono prescritti glucosio ed ematina. Se tutto il resto fallisce, può essere prescritto un trapianto di midollo osseo.
- L'anemia emolitica falciforme è più comune di altre e, di regola, i rappresentanti della razza negroide ne sono sensibili. Questa forma di anemia può manifestarsi con dolore vascolare, trombosi e dolore addominale. I pazienti possono sviluppare febbre, l'urina diventa scura e la quantità di emoglobina nel sangue diminuisce. Si consiglia al paziente di somministrarlo grandi dosi liquidi. Gli antibiotici vengono prescritti anche per escludere complicazioni infettive. In casi particolarmente difficili può essere prescritta una trasfusione di globuli rossi concentrati o addirittura l'asportazione della milza.
Queste anemie sono caratterizzate da una distruzione patologicamente aumentata dei globuli rossi e possono essere ereditarie o acquisite. Da questo articolo imparerai cos'è l'anemia emolitica nei bambini: raccomandazioni cliniche, sintomi e classificazione della malattia, nonché come viene trattata la malattia del sangue.
Codice ICD-10
D58 Altre anemie emolitiche ereditarie
D59 Anemia emolitica acquisita
La malattia del sangue si verifica a causa della maggiore distruzione delle cellule eritroidi. Possono essere:
- ereditario o acquisito;
- con tipo di emolisi intravascolare o intracellulare;
- associati ad anomalie interne dei globuli rossi (RBC) stessi o a influenze esterne.
Il quadro clinico è dominato da itterizia e sindrome emorragica. Nell'esame del sangue si riduce la concentrazione di Hb, il contenuto di eritrociti e piastrine. Vengono espresse anisocitosi, poichilocitosi, microsferocitosi, vengono rilevate cellule “stiloidi”, “a forma di elmo” e frammenti di globuli rossi.
IN analisi biochimiche sangue - aumento di LDH, bilirubina indiretta, possibile diminuzione del ferro sierico a causa della sua perdita nelle urine. Nelle urine - emosiderinuria, meno spesso - emoglobinuria.
Il test diretto di Coombs è negativo. Il criterio diagnostico differenziale è una combinazione di anemia, frammentazione dei globuli rossi, leucocitosi e trombocitopenia.
Il quadro clinico dell'anemia emolitica nei bambini è vario, dalle forme asintomatiche a in pericolo di vita. L'anemia è caratterizzata da una triade di sintomi: ittero, splenomegalia, anemia. Spesso si verifica un ritardo sviluppo fisico, anomalie del cranio e dello scheletro facciale. Gli esami del sangue rivelano una diminuzione della concentrazione di Hb, reticolocitosi, microsferocitosi e uno spostamento della curva di Price-Jones a sinistra. La resistenza osmotica dei globuli rossi è ridotta. Il corso di moderato e forme gravi La malattia è talvolta accompagnata da esacerbazioni.
- Una esacerbazione si verifica spontaneamente o sullo sfondo di un'infezione: appare o si intensifica l'ittero, le dimensioni della milza aumentano e diventa doloroso. Nel sangue diminuisce la concentrazione di Hb e il contenuto dei globuli rossi, aumenta la reticolocitosi e aumenta la concentrazione di bilirubina indiretta e LDH. La prima crisi, che si manifesta in modo atipico e viene raramente diagnosticata, può svilupparsi durante il periodo neonatale.
- La crisi aplastica nell'anemia emolitica è solitamente provocata da un'infezione da parvovirus (parvovirus B19), che lascia un'immunità duratura, quindi tale crisi si sviluppa nei pazienti una volta nella vita. La concentrazione di Hb e il contenuto di globuli rossi, e talvolta di leucociti e piastrine, diminuiscono rapidamente. Il contenuto di bilirubina e il numero di reticolociti non aumentano. La condizione dei pazienti è spesso grave a causa dello sviluppo di ipossiemia e ipossia. Relativamente spesso, i pazienti con sferocitosi ereditaria sviluppano colelitiasi.

Sintomi
- Clinicamente, i sintomi si manifestano con pallore con una sfumatura giallo limone, periodicamente - evidente ittero, ritardo nello sviluppo fisico e talvolta mentale, stimmi congeniti (cranio a torre, ampio ponte del naso, palato alto, prognatismo, ecc.);
- Cambiamenti espressi del sistema cardiovascolare;
- Significativo ingrossamento e ispessimento della milza e, in misura minore, del fegato;
- Ipogenitalismo;
- Esacerbazioni periodiche emolitiche e aplastiche (iporigenerative), che aumentano drasticamente le manifestazioni di anemia iper o iporigenerativa.
L'anemia emolitica è caratterizzata da: segni di laboratorio:
- microsferocitosi in presenza di eritrociti normocromici o leggermente ipercromici ed elevato indice di colore;
- diminuzione della resistenza osmotica minima dei globuli rossi con aumento della massima;
- reticolocitosi, che raggiunge il 40-50% o più;
- aumento del livello di bilirubina indiretta con campione negativo pettini;
- ricchezza elementi cellulari con predominanza del germe eritroide nel midollo osseo puntato.
Le crisi aplastiche, che di solito durano 1-2 settimane, sono accompagnate dai seguenti sintomi: aumento della temperatura corporea, debolezza, svenimento, mal di testa, forte pallore (senza ittero) e un leggero ingrossamento della milza. Allo stesso tempo, si osserva una diminuzione dell'indice del colore, l'ipocromia dei globuli rossi, la reticolocitopenia, meno spesso la trombocitopenia, l'inibizione del germoglio eritroide del midollo osseo.
Al di fuori di un attacco con lieve e forma moderata L'anemia non viene trattata. In caso di riacutizzazione è necessario: terapia infusionale, trasfusione di globuli rossi quando la concentrazione di Hb scende al di sotto di 70 g/l. La splenectomia è indicata nelle forme moderate gravi o complicate.
Prima dell'intervento chirurgico, è consigliabile vaccinarsi con vaccini pneumococcici e meningococcici polivalenti, nonché con vaccino Haemophilus influenzae, poiché dopo la splenectomia i pazienti sono a rischio più frequente e grave di infezioni virali e virali infezioni batteriche.
Per i bambini sotto i 6 anni a cui sono stati diagnosticati sintomi di anemia, è preferibile sottoporsi a un'operazione alternativa: l'occlusione endovascolare a raggi X dei vasi splenici, che preserva la funzione dell'organo e riduce l'emolisi.
Trattamento dell'anemia emolitica meccanica
Comprende la terapia, nonché la plasmaferesi, la trasfusione di grandi dosi di plasma fresco congelato e, se necessario, di globuli rossi. Sviluppo di nuovi metodi utilizzando dosi elevate Ig somministrate per via endovenosa (400 mg/kg/die o più) e inibitori dell'apoptosi.
Il metodo di scelta per il trattamento dell'anemia emolitica è, quanto più possibile, la splenectomia. prime date, che non elimina la malattia, ma porta alla scomparsa o all'attenuazione dei sintomi clinici. Durante i periodi di attacchi, il riposo a letto, il trapianto del fegato, la terapia sintomatica e le trasfusioni di sangue sono indicati solo quando il livello di emoglobina scende a 70 g/l. Per le crisi rigenerative: somministrazione giornaliera di globuli rossi (7 ml/kg), prednisolone orale (1 - 1,5 mg/kg al giorno), soluzione di glucosio al 5 - 10% con insulina e vitamine C, B1, B2 per via endovenosa, vitamine B12 ( 100 - 200 mcg/kg) e B6 (15 - 50 mg/giorno) per via intramuscolare. La stimolazione dell'eritropoiesi viene effettuata fino alla comparsa della reazione dei reticolociti.
Previsione: Con un trattamento adeguato e tempestivo, la prognosi è favorevole.
Anemie emolitiche ereditarie non sferocitiche
Queste malattie sono causate da una diminuzione congenita dell'attività degli enzimi dei globuli rossi, molto spesso della glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G-6-PD). Si manifestano come riacutizzazioni a qualsiasi età. Viene provocata l'emolisi situazioni stressanti, malattie intercorrenti, mangiare fave (favismo), assumere farmaci e vitamine: sulfamidici, nitrofurani, salicilati, derivati del chinino, antiossidanti, acido ascorbico, analoghi sintetici della vitamina K, ecc. Nel periodo neonatale, una tale crisi di anemia emolitica può servire come uno dei fattori patogenetici nello sviluppo dell'encefalopatia da bilirubina (kernittero), anche in assenza di conflitto immunologico. L'emolisi acuta è accompagnata da anemia significativa (normo- o macrocitica, iperrigenerativa), dalla comparsa di corpi di Heinz negli eritrociti e, meno comunemente, da emoglobinuria, anuria e shock ipovolemico. la diagnosi è confermata dalla determinazione diretta della presenza di G-6-PD e di altri enzimi (piruvato chinasi, sistema glutatione).
A attacco acuto i farmaci terapeutici che hanno causato l'emolisi vengono interrotti e viene somministrata una soluzione di glucosio per via endovenosa.
- In caso di anemia grave si esegue la trasfusione di sangue;
- Per l'iperbilirubinemia nei neonati: trasfusione di sangue sostitutiva;
- In caso di anuria prolungata è indicata la dialisi extracorporea
Previsione Il trattamento dell’anemia emolitica è favorevole nella maggior parte dei casi.
Anemia emolitica autoimmune acquisita "idiopatica" (AHA)
L'anemia è causata dalla formazione di autoanticorpi anti-eritrociti sotto l'influenza di fattori fisico-chimici (radiazioni, ustioni, insolazione, congelamento, ecc.), infezioni batteriche e virali e tossine, farmaci, seguiti dalla degradazione dei globuli rossi. Si osservano in ragazzi e ragazze di tutte le età, a partire dal periodo neonatale.
A differenza dell'anemia da carenza, i sintomi si sviluppano in modo acuto, sotto forma di crisi con anemia grave, leggero ittero, reazione febbrile fino all'ipertermia, fenomeni di intossicazione, fegato prevalentemente ingrossato, anemia normo- o ipercromica, iperrigenerativa (dal 2° al 4° giorno della malattia), il livello della bilirubina indiretta è moderatamente aumentato, quello del ferro sierico in modo significativo. Il test diretto di Coombs è negativo nella maggior parte dei pazienti, ma il test di emoagglutinazione aggregata di Idelson è positivo. Nel midollo osseo punteggiato c'è irritazione della spora eritroide.
L'anemia emolitica viene trattata con la terapia con glucocorticoidi, che è efficace in 2/3 dei pazienti. Se non vi è alcun effetto, vengono utilizzati immunosoppressori (6-mercaptopurina, azatioprina), irradiazione timica, timectomia, splenectomia. Al momento dell'esacerbazione, con una forte diminuzione dell'emoglobina, viene eseguita una trasfusione di globuli rossi lavati o sangue di un donatore appositamente selezionato.
Prognosi del trattamento: nella maggior parte dei casi si ottiene una remissione clinica favorevole o un recupero completo; a volte la morte è possibile.
Anemie emolitiche indotte da farmaci
Il trattamento viene effettuato con l'aiuto di farmaci (ad esempio salicilati, sulfamidici, nitrofurani), ma dopo averli assunti sono possibili l'emolisi degli eritrociti e un aumento della concentrazione di bilirubina nel sangue.
Anemie emolitiche ereditarie
Membranopatie eritrocitarie (sferocitosi ereditaria o malattia di Minkowski-Choffard). La sferocitosi ereditaria, o anemia di Minkowski-Choffard, si manifesta più spesso all'età di 3-15 anni. La picnocitosi infantile può svilupparsi già nei primi giorni di vita, nei neonati prematuri - a 3-4 settimane, soprattutto con carenza di vitamina E. Come risultato dell'emolisi, si sviluppa un'iperbilirubinemia transitoria. Se è possibile prevenire lo sviluppo kernittero, la prognosi è generalmente favorevole.
L'anemia sferocitica ereditaria (Minkowski-Shoffard) è caratterizzata da un aumento dell'emolisi che si verifica negli organi del sistema reticoloendoteliale a causa di un difetto congenito nelle strutture lipidiche della membrana dei globuli rossi, che porta alla penetrazione degli ioni sodio nella cellula e perdita di ATP. La durata della vita dei globuli rossi difettosi è di soli 8-10 giorni. Vengono distrutti principalmente nella milza. I primi sintomi dell'anemia emolitica nei bambini possono essere rilevati a qualsiasi età, a partire dal periodo neonatale.
La prevalenza della sferocitosi ereditaria o malattia di Minkowski-Choffard è di circa 1:5000, escluse le forme lievi e asintomatiche della malattia.
Nel 70% dei casi la malattia di Minkowski-Choffard è 5R, nel 30% si verifica a seguito di mutazioni spontanee. La malattia si basa su un difetto molecolare delle proteine della membrana eritrocitaria, che ne riduce la stabilità osmotica. La durata della vita dei globuli rossi si riduce a 8-10 giorni, le cellule difettose vengono distrutte nella milza.
La più comune delle emoglobinopatie è anemia falciforme. Anche la talassemia appartiene a questo gruppo. Le emoglobinopatie insorgono come risultato di un'alterata sintesi dell'Hb dovuta alla mutazione dei geni della catena globinica. Le malattie di questo gruppo sono comuni nei paesi della zona tropicale e subtropicale e di solito si sviluppano entro la fine del primo anno di vita.
Tra le enzimopatie eritrocitarie, la più comune è l'anemia causata dal deficit di glucosio-fosfato deidrogenasi. La carenza di questo enzima viene rilevata più spesso nei residenti del Mediterraneo, dell'Est, dell'Asia e dell'Africa. La malattia si manifesta nei neonati.
Anemie emolitiche microangiopatiche meccaniche
Appaiono a causa della frammentazione traumatica dei globuli rossi. Le cause del guasto meccanico possono essere i seguenti fattori:
- Stenosi o aneurisma aortico.
- Restringimento o ostruzione dei piccoli vasi sanguigni(DIC, sindrome emolitico-uremica, sindrome di Moshkovich, vasculite sistemica, malattie renali ed epatiche, polmonite streptococcica).
- Danni alle valvole cardiache e grandi vasi(valvole protesiche).
- Corsa su lunghe distanze, sport di contatto, ecc. Le principali cause di frammentazione dei globuli rossi sono: piccoli vasi: danni ai vasi stessi, formazione di coaguli di sangue e di filamenti di fibrina nel sangue.
Anemia emolitica autoimmune
La variante più comune di questo gruppo di anemia, che si sviluppa a seguito di un conflitto immunitario, è la formazione di AT su Ags superficiali alterati dei propri globuli rossi.
I complessi “AT” eritrocitari risultanti subiscono agglutinazione tra loro in seguito a una leggera esposizione al freddo (emolisi intravascolare) o vengono assorbiti dai macrofagi splenici (emolisi intracellulare).
Classificazione (basata sulle differenze negli autoanticorpi):
- AT Termico (reagisce con i globuli rossi ad una temperatura corporea di almeno 37°C);
- AT freddo (reagisce con i globuli rossi a temperature inferiori a 37°C);
- Emolisi bifasiche (fissate sui globuli rossi quando qualsiasi parte del corpo si raffredda e causano emolisi con successivo aumento della temperatura corporea fino a 37 ° C).
La prevalenza è 1:75.000 - 1:80.000 e nell'80% dei pazienti di qualsiasi età l'anemia emolitica è causata dal calore AT (agglutinine). Nei bambini, nel 79% dei casi sono diretti contro RhAr. L'anemia con AT fredda è meno comune, più spesso dopo un'infezione virale nei bambini piccoli e negli anziani.
Questa malattia può essere sia idiopatica che sintomatica (con infezione virale, malattie linfoproliferative, istiocitosi, assunzione di farmaci).
Sintomi dell'anemia emolitica spesso iniziano con un attacco acuto con una combinazione di emolisi intracellulare e intravascolare. La temperatura corporea del paziente aumenta improvvisamente, compaiono debolezza, mancanza di respiro, tachicardia, ingiallimento della pelle e delle mucose, colorazione marrone o marrone delle urine e ingrossamento del fegato e della milza. Con un esordio graduale si verificano artralgia e dolore addominale.
Un esame del sangue rivela anemia normale o ipercromica, anisocitosi e lieve reticolocitosi. Possibile sviluppo di normoblastosi, sferocitosi, trombocitopenia, leucocitosi con spostamento formula dei leucociti A sinistra. La VES aumenta. Il test di Coombs è positivo (il test rileva il complesso “eritrocitiAT”).
Principi di base del trattamento:
- bloccando la sintesi di autoanticorpi (prednisolone, citostatici, ciclosporina),
- restrizione dell'accesso agli AT alle cellule bersaglio (Ig purificate ad alte dosi, prednisolone),
- stimolazione della rigenerazione delle cellule del sangue (acido folico).
- Viene utilizzato anche il trattamento chirurgico (splenectomia).
- Se necessario, vengono effettuate trasfusioni di globuli rossi lavati.
Ora sai tutto sul trattamento e sui sintomi dell'anemia emolitica nei bambini. Salute a tuo figlio!
Anemia emolitica– si tratta di un complesso di sintomi clinici ed ematologici che si verifica a causa di una riduzione della durata di funzionamento dei globuli rossi, a causa della loro maggiore degradazione. Questa patologia combina un gruppo di malattie ereditarie e acquisite, la cui patogenesi è dominata da segni di emolisi degli eritrociti senza diminuzione dell'emoglobina in sangue periferico. Secondo le statistiche mondiali, nella struttura della morbilità tra le patologie del sangue, la quota condizioni emolitiche rappresenta almeno il 5%, di cui prevale tipi ereditari anemia emolitica.
I segni dell'anemia emolitica si verificano solo quando c'è un chiaro squilibrio tra la proliferazione cellule del sangue serie di eritrociti e distruzione dei globuli rossi nel flusso sanguigno circolante, mentre la funzione compensatoria del midollo osseo (aumento della proliferazione dei reticolociti) è impoverita.
Anemia emolitica autoimmune
Il principale fattore provocante nell'insorgenza dell'anemia emolitica autoimmune è la sintesi di anticorpi contro i propri globuli rossi, che il corpo percepisce come antigeni estranei. La manifestazione dell'anemia emolitica autoimmune si verifica sullo sfondo di qualsiasi malattia sintomatica come complicazione (malattie sistemiche tessuto connettivo, emoblastosi, epatite cronica aggressiva, ulcerosa aspecifica, neoplasie maligne) o come unità nosologica indipendente.
Nonostante sviluppo rapido medicina sul campo misure diagnostiche malattie del sangue, fino ad oggi non è possibile stabilire una causa affidabile per lo sviluppo dell'anemia emolitica autoimmune.
Tutto manifestazioni cliniche L'anemia emolitica autoimmune non dipende dal fattore eziologico. Molto spesso, i pazienti sperimentano un decorso lentamente progressivo della malattia. Le prime manifestazioni della malattia sono debolezza generale, dolori articolari, bassa temperatura corporea e dolore addominale. Un esame obiettivo del paziente rivela un marcato pallore e pascolamento della pelle, un ittero gradualmente crescente e un aumento delle dimensioni della milza e del fegato.
Nel 50% dei casi i pazienti manifestano anemia emolitica acuta di natura autoimmune, caratterizzata da un'insorgenza improvvisa della malattia e da un quadro clinico violento. In questa situazione, le numerose lamentele del paziente vengono alla ribalta quando completa assenza cambiamenti durante un esame obiettivo del paziente. I principali disturbi che il paziente presenta sono: grave debolezza e riduzione delle prestazioni, battito cardiaco accelerato, sensazione di mancanza d'aria, aumento della temperatura corporea fino a 38-39 gradi Celsius, nausea e vomito non associati all'assunzione di cibo, dolore alla cintura. nell'addome superiore. Le manifestazioni esterne dell'emolisi aumentano solo il giallo della pelle in assenza di un aumento delle dimensioni del fegato e della milza.
I segni di anemia emolitica di natura autoimmune in un esame del sangue di laboratorio sono: reticolocitosi elevata del 200-300%, diminuzione del numero di globuli rossi con un indice di colore normale, lieve leucocitosi, numero di piastrine non modificato o leggermente ridotto. Un indicatore assoluto della natura autoimmune dell'anemia è un aumento della VES a numeri elevati. In alcuni casi è possibile identificare microsferociti o globuli rossi frammentati. A ricerca biochimica sangue, si determina un aumento della bilirubina indiretta e dell'ipergammaglobulinemia. Per determinare la presenza di anticorpi sui globuli rossi viene eseguito uno specifico test di Coombs, che diventa nettamente positivo nell'anemia emolitica autoimmune.
La prognosi per la vita e le prestazioni nell'anemia emolitica autoimmune dipende dal decorso, dalla gravità e dall'efficacia della terapia per la malattia di base che ha causato lo sviluppo dell'emolisi. Di norma, il recupero completo e il ripristino della capacità lavorativa non possono essere raggiunti con nessun metodo di trattamento. La remissione persistente si osserva solo dopo la splenectomia radicale e un lungo ciclo di terapia ormonale.
Cause dell'anemia emolitica
La causa dell'emolisi dei globuli rossi può essere qualsiasi malattia somatica e in tale situazione si sviluppa l'anemia emolitica acquisita.
Quando esposto all'uno o all'altro fattore eziologico, si sviluppa un quadro clinico di una condizione emolitica acuta o cronica.
Il decorso cronico dell'anemia emolitica si osserva durante il periodo parossistico emoglobinuria notturna, emoglobinuria fredda.
Sintomi dell'anemia emolitica
I sintomi classici dell'anemia emolitica si sviluppano solo con l'emolisi intracellulare dei globuli rossi e sono rappresentati da sindromi anemiche, itteriche e splenomegalia.
Il grado di manifestazione dei sintomi clinici, che indica lo sviluppo di una condizione anemica, dipende direttamente dalla velocità di distruzione dei globuli rossi e dalla reazione compensatoria del midollo osseo, come principale organo ematopoietico. I segni di anemia si sviluppano solo in una situazione in cui la durata della vita dei globuli rossi è ridotta a 15 giorni invece di 120 giorni.
Secondo il corso, si distinguono l'anemia emolitica latente (compensata), cronica (con anemizzazione pronunciata) e crisi. Durante il decorso critico della malattia, le condizioni generali del paziente sono gravi, indipendentemente dal tipo di emolisi (intravascolare o intracellulare).
Durante una riacutizzazione, l'anemia emolitica si manifesta sotto forma di grave debolezza, riduzione delle prestazioni, vertigini, difficoltà respiratorie, aumento della frequenza cardiaca, dolore fastidioso nell'ipocondrio destro e sinistro. Un segno caratteristico dell'anemia emolitica acuta è l'ittero della pelle e delle mucose palato fine e sclera. All'esame obiettivo del paziente, nel 70% dei casi si osserva un ingrossamento della milza e una sporgenza del fegato da sotto l'arco costale di oltre 2 cm.
A causa dell'ispessimento e del ristagno della bile, viene provocata la formazione di calcoli nella cistifellea e dotti biliari, pertanto, i pazienti affetti da anemia emolitica spesso presentano disturbi caratteristici di epatite, colecistite e colangite ( dolore acuto nell'ipocondrio destro, nausea, vomito, brividi, aumento a breve termine temperatura corporea).
Nel corpo umano, l'emolisi fisiologica degli eritrociti si verifica costantemente nella milza. Durante la distruzione dell'emoglobina, la bilirubina indiretta viene rilasciata nel flusso sanguigno circolante, che successivamente subisce cambiamenti nella struttura e nella composizione nel fegato, nella cistifellea e nell'intestino. L'urobilina e la stercobilina risultanti vengono escrete insieme all'urina e alle feci, a seguito delle quali i pazienti spesso notano l'oscuramento delle urine e le feci di colore chiaro.
In una situazione in cui si verifica la distruzione intravascolare dei globuli rossi, i sintomi vengono alla ribalta sindrome anemica, mentre l'ittero e la splenomegalia sono estremamente rari. Questo tipo di anemia emolitica è caratterizzata da un decorso critico della malattia, che peggiora significativamente le condizioni del paziente. Sintomi caratteristici crisi emolitiche sono: debolezza generale, mal di testa pulsante, sensazione di mancanza d'aria, aumento della frequenza cardiaca, vomito incontrollabile non associato all'assunzione di cibo, fuoco di Sant'Antonio dolore lancinante nei quadranti superiori dell'addome e regione lombare, febbre, urina marrone scuro. In assenza di una terapia adeguata, si sviluppa rapidamente il quadro clinico dell'insufficienza renale acuta, che diventa causa di morte.
I segni di laboratorio dell'anemia emolitica sono: normocromica, iperrigenerativa e cambiamenti nella forma e dimensione dei globuli rossi (a forma di falce, ovali, microsferociti, a forma di bersaglio). Cambiamenti caratteristici L'anemia emolitica autoimmune è la leucocitosi con uno spostamento della formula dei leucociti a sinistra e una VES fortemente aumentata. La puntura del midollo osseo rivela iperplasia della linea rossa e una pronunciata reazione eritroblastica.
Anemia emolitica nei bambini
Nell'infanzia si osservano forme sia congenite che acquisite di anemia emolitica. Tutte le anemie emolitiche hanno in comune sintomi clinici, tuttavia, richiedono l'istituzione diagnosi accurata indicando la forma dell'anemia, poiché da questo dipendono ulteriori tattiche terapeutiche e il monitoraggio del paziente.
L'anemia emolitica congenita, fortunatamente, lo è malattia rara e non supera i 2 casi su 100.000 abitanti, tuttavia, dovresti prestare molta attenzione ai bambini che soffrono di questa forma di anemia, poiché trattare questi pazienti è estremamente difficile.
L'anemia emolitica ereditaria di Minkowski-Choffard è causata dalla manifestazione di un gene difettoso, ereditato con modalità autosomica dominante, che causa cambiamenti nella forma dei globuli rossi. La forma cambia a causa della rottura membrana cellulare, pertanto, diventa permeabile alla penetrazione degli ioni sodio in eccesso, provocando così il rigonfiamento dei globuli rossi. L'emolisi eccessiva di tali globuli rossi alterati avviene all'esterno della polpa splenica.
L'esordio della malattia si osserva nella prima infanzia e le prime manifestazioni sono l'ittero delle mucose e della pelle. Caratteristiche distintive Questa forma di anemia emolitica è una combinazione di sindrome anemica grave con anomalie dello sviluppo (forma del cranio dolicocefalica, naso a sella, posizione elevata del palato duro).
I criteri principali per stabilire una diagnosi sono “ anemia ereditaria Minkowski-Shoffar" sono: anemia normocromica, iperrigenerativa, microsferocitosi eritrocitaria, ridotta resistenza osmotica degli eritrociti, aumento della bilirubina indiretta nel sangue, aumento delle dimensioni della milza.
La prognosi per la vita e la salute è favorevole con questa forma di anemia e si verifica solo dopo splenectomia radicale.
Un'altra forma di anemia emolitica ereditaria che si verifica durante l'infanzia è l'anemia causata dalla mancanza di attività del G-6-FDG, caratterizzata da una modalità di trasmissione autosomica recessiva.
Un segno caratteristico di questa patologia è la comparsa di emolisi intravascolare spontanea dopo l'assunzione determinati gruppi medicinali(sulfamidici, derivati del chinino, antiaggreganti piastrinici, cloramfenicolo, tubazide) o consumo di legumi.
Le manifestazioni cliniche si verificano 2-3 giorni dopo l'uso del farmaco e si manifestano sotto forma di grave debolezza, nausea e vomito, aumento della frequenza cardiaca, febbre febbrile, anuria e insufficienza renale acuta. Le caratteristiche distintive di questa forma di anemia emolitica ereditaria sono l'emoglobinuria e l'emosiderinuria.
I cambiamenti caratteristici nei parametri del sangue periferico sono: una diminuzione del numero di eritrociti e un'elevata reticolocitosi, la presenza di corpi di Heinz nell'eritrocito durante la colorazione sopravitale, un aumento della resistenza osmotica degli eritrociti. IN punteggiato del midollo osseo si determina un germe rosso iperplastico dell'ematopoiesi.
Questo tipo di anemia è caratterizzato da un decorso di crisi, pertanto, come misura preventiva, il bambino deve essere completamente escluso dalla dieta. prodotti legumi, e anche prevenire l'uso di farmaci del gruppo a rischio. A causa del fatto che l'anemia ereditaria si verifica spesso con lo sviluppo di una crisi emolitica fulminante, accompagnata da insufficienza renale acuta, la prognosi per la vita e la salute del bambino in questo caso è sfavorevole.
La forma più comune di anemia emolitica ereditaria nell'infanzia è quella in cui i globuli rossi contengono patologicamente un eccesso di globina, che promuove l'aggregazione accelerata e la distruzione dei globuli rossi non solo nella milza, ma anche nel midollo osseo.
Le prime manifestazioni di talassemia si osservano già nel periodo neonatale e si manifestano con grave sindrome anemica, ittero e splenomegalia in combinazione con anomalie dello sviluppo ( forma quadrata cranio, arco zigomatico sporgente, faccia di tipo mongoloide, canna nasale appiattita). I bambini affetti da talassemia sperimentano ritardi non solo nello sviluppo fisico ma anche in quello psicomotorio.
Caratteristica segni di laboratorio talassemia nei bambini sono: anemia grave (diminuzione del livello di emoglobina inferiore a 30 g/l), ipocromia (diminuzione dell'indice di colore inferiore a 0,5), reticolocitosi, eritrociti a forma di bersaglio durante l'esame di uno striscio, aumento della resistenza osmotica degli eritrociti, alto livello di bilirubina indiretta. Il criterio assoluto per diagnosticare la talassemia è livello aumentato emoglobina fetale (più del 30%).
La talassemia è una patologia costantemente progressiva, che non è caratterizzata da periodi di remissione, e quindi il tasso di mortalità per questa malattia è molto alto.
Trattamento dell'anemia emolitica
Per ottenere il massimo risultato positivo dal trattamento dell'anemia emolitica, prima di tutto, deve essere compiuto ogni sforzo per chiarire in modo affidabile la forma di questa malattia, poiché ogni regime di trattamento deve essere determinato eziopatogeneticamente.
Pertanto, la splenectomia radicale viene utilizzata come metodo di trattamento prioritario per l'anemia emolitica microsferocitica ereditaria. Indicazioni assolute per la splenectomia vengono considerati: un decorso critico della malattia con frequenti periodi di esacerbazione, un pronunciato grado di anemia e colica epatica. Nella maggior parte dei casi, dopo la splenectomia, si osserva una remissione del 100% senza recidive della malattia, anche nonostante la presenza di microsferociti nel sangue. In una situazione in cui l'emolisi è accompagnata dalla comparsa di calcoli nella cistifellea, si consiglia di combinare la splenectomia con la colecistectomia.
Come misura preventiva, si raccomanda ai pazienti di assumere coleretico a lungo termine (Allochol 1 compressa ad ogni pasto), antispasmodico (Riabal 1 capsula 2 volte al giorno), esercizio periodico intubazione duodenale. In situazioni in cui è presente un grado pronunciato di anemia, è consigliabile utilizzare la trasfusione sintomatica di globuli rossi, tenendo conto dell'appartenenza al gruppo.
Nei casi di anemia emolitica ereditaria causata da un difetto del G-6-FDG, si raccomanda una terapia disintossicante (200 ml di soluzione isotonica di cloruro di sodio per via endovenosa), nonché azioni preventive per prevenire la coagulazione intravascolare disseminata (eparina 5000 unità per via sottocutanea 4 volte al giorno).
L'anemia emolitica autoimmune risponde bene al trattamento con farmaci ormonali, che vengono utilizzati non solo per alleviare una crisi emolitica, ma anche come trattamento a lungo termine. Per determinare dosaggio ottimale Bisogna prendere in considerazione il prednisolone salute generale paziente, nonché i parametri del sangue periferico. Una dose giornaliera adeguata di Prednisolone in questa situazione è considerata pari a 1 mg/kg di peso corporeo, ma se non si riscontra alcun effetto è consentito aumentare la dose a 2,5 mg/kg.
Nelle situazioni in cui l'anemia emolitica autoimmune si manifesta in forma grave, è consigliabile associare la terapia disintossicante (Neohemodez 200 ml flebo endovenosa) alla trasfusione di globuli rossi, tenendo conto del gruppo di appartenenza. La splenectomia radicale viene utilizzata solo se non vi è alcun effetto derivante dall'uso di farmaci terapia conservativa e deve essere accompagnato dalla prescrizione di farmaci citostatici (Ciclofosfamide 100 mg 1 volta/die, Azatioprina dose giornaliera 200 mg). Bisognerebbe tenerne conto controindicazione assoluta all'uso di farmaci citostatici è infanzia, poiché i farmaci di questo gruppo possono causare un effetto mutageno.
Separatamente, dovremmo soffermarci su un metodo di trattamento come la trasfusione di globuli rossi scongelati o lavati. La trasfusione di globuli rossi dovrebbe essere giustificata dalla gravità della sindrome anemica e condizione generale paziente ed è fondamentale valutare la risposta del paziente alla trasfusione di sangue. Molto spesso, i pazienti che hanno subito ripetute trasfusioni di globuli rossi manifestano reazioni post-trasfusionali, che ne sono la causa selezione individuale sangue utilizzando il test di Coombs indiretto.
In alcuni casi, l'anemia emolitica risponde bene al trattamento con l'uso di farmaci ormonali anabolizzanti (Retabolil 25 mg per via intramuscolare, Nerobol 5 mg una volta al giorno). COME terapia sintomatica Si consiglia l'uso di farmaci antiossidanti (vitamina E 10 mg per via intramuscolare) e in caso di concomitante carenza di ferro - per via orale integratori di ferro(Ferrum-Lek 10 ml 1 g./giorno).
L'anemia emolitica è un gruppo di malattie associate a una diminuzione della durata della circolazione dei globuli rossi nel sangue a causa della loro distruzione o emolisi. Rappresentano oltre l'11% di tutti i casi di anemia e oltre il 5% di tutte le malattie ematologiche.
In questo articolo parleremo delle cause di questa malattia e del trattamento di questa difficile malattia.
Qualche parola sui globuli rossi
I globuli rossi sono globuli rossi che trasportano ossigeno.Gli eritrociti, o globuli rossi, sono cellule del sangue la cui funzione principale è trasportare l'ossigeno agli organi e ai tessuti. I globuli rossi si formano nel midollo osseo rosso, da dove le loro forme mature entrano nel flusso sanguigno e circolano in tutto il corpo. La durata della vita dei globuli rossi è di 100-120 giorni. Ogni giorno circa l'1% di loro muore e viene sostituito da altrettante nuove cellule. Se la durata della vita dei globuli rossi si riduce, nel sangue periferico o nella milza ne vengono distrutti più di quanti hanno il tempo di maturare nel midollo osseo: l'equilibrio viene interrotto. Il corpo risponde a una diminuzione del contenuto di globuli rossi nel sangue aumentando la loro sintesi nel midollo osseo, l'attività di quest'ultimo aumenta significativamente - 6-8 volte. Di conseguenza, nel sangue viene determinato un numero maggiore di cellule precursori dei globuli rossi giovani, i reticolociti. La distruzione dei globuli rossi con il rilascio di emoglobina nel plasma sanguigno è chiamata emolisi.
Cause, classificazione, meccanismi di sviluppo dell'anemia emolitica
A seconda della natura del decorso, l'anemia emolitica può essere acuta o cronica.
A seconda del fattore causale, la malattia può essere congenita (ereditaria) o acquisita:
1. Anemia emolitica ereditaria:
- che si manifesta in connessione con una violazione della membrana eritrocitaria - membranopatia (ellittocitosi, microcitosi o anemia di Minkovsky-Choffar);
- associato a una violazione della struttura o patologia della sintesi delle catene di emoglobina - emoglobinopatie (porfiria, talassemia, anemia falciforme);
- derivanti da disturbi enzimatici nei globuli rossi - fermentopatia (deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi).
2. Anemia emolitica acquisita:
- autoimmune (si verifica durante la trasfusione sangue incompatibile; Quando ; a causa dell'assunzione di alcuni farmaci - sulfamidici, antibiotici; sullo sfondo di alcune infezioni virali e batteriche: herpes simplex, epatite B e C, Virus Epstein-Barr, Escherichia coli e Hemophilus influenzae; linfomi e leucemie, malattie sistemiche del tessuto connettivo, come il lupus eritematoso sistemico);
- causato da danni meccanici alla membrana dei globuli rossi - macchina cuore-polmone, valvole cardiache protesiche;
- che si manifesta in connessione con cambiamenti nella struttura della membrana eritrocitaria causata da una mutazione somatica - malattia di Marchiafava-Micheli o emoglobinuria parossistica notturna;
- derivante da danni chimici ai globuli rossi - a seguito di intossicazione da piombo, benzene, pesticidi e dopo morsi di serpente.
Patogenesi dell'anemia emolitica in diverse opzioni le malattie sono diverse IN schema generale può essere rappresentato così. I globuli rossi possono essere distrutti in due modi: intravascolare e intracellulare. La loro maggiore lisi all'interno dei vasi è spesso causata da danni meccanici, dall'effetto delle tossine sulle cellule dall'esterno e dalla fissazione delle cellule immunitarie sulla superficie degli eritrociti.
L’emolisi extravascolare dei globuli rossi si verifica nella milza e nel fegato. Si intensifica se le proprietà della membrana eritrocitaria cambiano (ad esempio, se su di essa sono fissate immunoglobuline), così come se la capacità dei globuli rossi di cambiare forma è limitata (questo complica notevolmente il loro normale passaggio attraverso i vasi della milza ). Nelle diverse forme di anemia emolitica, questi fattori sono combinati a vari livelli.
Segni clinici e diagnosi di anemia emolitica
I segni clinici di questa malattia sono la sindrome emolitica e, nei casi più gravi, la crisi emolitica.
Le manifestazioni cliniche ed ematologiche della sindrome emolitica sono diverse; l'emolisi intravascolare e intracellulare sono diverse.
Segni di emolisi intravascolare:
- aumento della temperatura corporea;
- urina rossa, marrone o nera - a causa del rilascio di emoglobina o emosiderina;
- segni di emosiderosi organi interni- depositi di emosiderina in essi (se si deposita nella pelle - oscuramento della stessa, nel pancreas - diabete mellito, nel fegato - disfunzione e ingrossamento dell'organo);
- la bilirubina libera viene determinata nel sangue;
- viene determinato anche nel sangue, l'indice di colore è compreso tra 0,8 e 1,1.
L'emolisi intracellulare è caratterizzata dai seguenti sintomi:
- ingiallimento della pelle, mucose visibili, sclera;
- fegato e milza ingrossati;
- il contenuto di emoglobina e globuli rossi nel sangue è ridotto - anemia; l'indice di colore è 0,8-1,1, il numero di reticolociti è aumentato al 2% o più;
- la resistenza osmotica dei globuli rossi è ridotta;
- determinato in un esame del sangue biochimico importo aumentato bilirubina indiretta;
- determinato nelle urine un gran numero di sostanze – urobilina;
- nelle feci - stercobilina;
- nel midollo osseo punteggiato il contenuto di eritro e normoblasti è aumentato.
La crisi emolitica è uno stato di massiccia emolisi dei globuli rossi, caratterizzata da forte peggioramento condizioni generali del paziente, progressione acuta dell'anemia. Richiede il ricovero immediato e il trattamento d'urgenza.
Principi di trattamento dell'anemia emolitica
Prima di tutto, gli sforzi del medico nel trattamento di questa malattia dovrebbero mirare ad eliminare la causa dell'emolisi. Parallelamente, viene effettuata la terapia patogenetica, di norma si tratta dell'uso di farmaci immunosoppressori che sopprimono il sistema immunitario, terapia sostitutiva(trasfusione di componenti del sangue, in particolare globuli rossi conservati), disintossicazione (infusione di soluzione salina, reopoliglucina e così via), nonché cercare di eliminare i sintomi della malattia che sono spiacevoli per il paziente.
Diamo uno sguardo più da vicino all'individuo forme cliniche anemia emolitica.
Anemia di Minkowski-Choffard o microsferocitosi ereditaria
Con questa malattia aumenta la permeabilità della membrana eritrocitaria e gli ioni sodio penetrano in essa. Il tipo di ereditarietà è autosomica dominante. I primi segni compaiono, di regola, durante l'infanzia o l'adolescenza.
Procede a ondate, i periodi di stabilità vengono improvvisamente sostituiti da crisi emolitiche.
Caratteristica è la seguente triade di segni:
- diminuzione della resistenza osmotica dei globuli rossi;
- microsferocitosi (la predominanza di eritrociti di forma alterata - microsferociti, che non sono flessibili, a causa dei quali anche i microtraumi portano alla distruzione cellulare - lisi);
- reticolocitosi.
Sulla base dei dati di cui sopra, possiamo dire che un esame del sangue determina l'anemia: normo o microcitica, iperrigenerativa.
Clinicamente, la malattia si manifesta con lieve ittero (aumento del livello di bilirubina indiretta nel sangue), ingrossamento della milza e del fegato. I cosiddetti stimmi della disembriogenesi non sono rari: "teschio a torre", dentatura irregolare, lobo dell'orecchio attaccato, occhi a mandorla e così via.
Il trattamento per le forme lievi di anemia di Minkovsky-Shofar non viene effettuato. In caso di decorso grave, il paziente è indicato per la splenectomia.
Talassemia
Si tratta di un intero gruppo di malattie ereditarie che insorgono a causa di una violazione della sintesi di una o più catene di emoglobina. Può essere sia omo che eterozigote. Di norma, la formazione di una delle catene di emoglobina viene interrotta più spesso e viene prodotta la seconda quantità normale, ma poiché ce n'è di più, l'eccesso precipita.
I seguenti segni ti aiuteranno a sospettare la talesemia:
- milza significativamente ingrossata;
- malformazioni congenite: cranio a torre, labbro leporino e altre;
- anemia grave con indice di colore inferiore a 0,8 – ipocromica;
- i globuli rossi hanno una forma bersaglio;
- reticolocitosi;
- alti livelli di ferro e bilirubina nel sangue;
- l'emoglobina A2 e l'emoglobina fetale vengono determinate nel sangue.
La diagnosi è confermata dalla presenza di questa malattia in uno o più parenti stretti.
Il trattamento viene effettuato durante i periodi di esacerbazione: al paziente viene prescritta una trasfusione di globuli rossi in scatola e l'assunzione di vitamina B9 (acido folico). Se la milza è significativamente ingrandita, viene eseguita la splenectomia.
Anemia falciforme
 Una crisi emolitica richiede il ricovero urgente del paziente e un trattamento di emergenza. cure mediche.
Una crisi emolitica richiede il ricovero urgente del paziente e un trattamento di emergenza. cure mediche. Questa forma di emoglobinopatie è la più comune. Di norma, ne soffrono le persone della razza negroide. La malattia è caratterizzata dalla presenza nel paziente di un tipo specifico di emoglobina - emoglobina S, nella cui catena uno degli aminoacidi - la glutammina - è sostituito da un altro - valina. A causa di questa sfumatura, l'emoglobina S è 100 volte meno solubile dell'emoglobina A, si sviluppa il fenomeno della falce, i globuli rossi acquisiscono forma specifica- hanno la forma di una falce, diventano meno flessibili - non cambiano forma, motivo per cui rimangono facilmente intrappolati nei capillari. Clinicamente ciò si manifesta con frequenti trombosi in vari organi: i pazienti lamentano dolore e gonfiore delle articolazioni, dolore intenso nell'addome si verificano infarti dei polmoni e della milza.
Possono svilupparsi crisi emolitiche, manifestate dal rilascio di urina nera e macchiata di sangue, da una forte diminuzione del livello di emoglobina nel sangue e da febbre.
Al di fuori di una crisi, l'anemia viene rilevata dall'analisi del sangue del paziente grado medio gravità con presenza di globuli rossi a forma di falce nello striscio, reticolocitosi. Anche il livello di bilirubina nel sangue aumenta. Il midollo osseo contiene un gran numero di eritrocariociti.
L’anemia falciforme può essere difficile da controllare. Il paziente necessita di una somministrazione massiccia di liquidi, a seguito della quale diminuisce il numero di globuli rossi modificati e diminuisce il rischio di trombosi. Parallelamente vengono effettuate l'ossigenoterapia e la terapia antibiotica (per combattere le complicanze infettive). Nei casi più gravi, il paziente è indicato per la trasfusione di globuli rossi e persino per la splenectomia.
Porfiria
Questa forma di anemia emolitica ereditaria è associata a una violazione della sintesi delle porfirine, pigmenti naturali che compongono l'emoglobina. Si trasmette sul cromosoma X e di solito si verifica nei ragazzi.
I primi segni della malattia compaiono nell'infanzia: l'anemia ipocromica, che progredisce con il passare degli anni. Con il passare del tempo compaiono segni di deposito di ferro negli organi e nei tessuti (emosiderosi):
- se si deposita ferro nella pelle, diventa di colore scuro;
- quando un oligoelemento si deposita nel fegato, quest'ultimo aumenta di dimensioni;
in caso di accumulo di ferro nel pancreas, si sviluppa carenza di insulina: .
I globuli rossi assumono la forma di un bersaglio e sono di diverse dimensioni e forme. I livelli di ferro nel siero sono 2-3 volte più alti valori normali. La saturazione della transferrina tende al 100%. I sideroblasti vengono rilevati nel midollo osseo e i granuli di ferro si trovano attorno ai loro nuclei negli eritrocariociti.
È possibile anche una variante acquisita della porfiria. Di norma, viene diagnosticato a causa di intossicazione da piombo. Clinicamente, questo si manifesta come segni di danno sistema nervoso(encefalite, polineurite), tratto digerente(coliche di piombo), pelle (colore pallido con una sfumatura terrosa). Sulle gengive appare uno specifico bordo di piombo. La diagnosi viene confermata esaminando il livello di piombo nelle urine del paziente: in questo caso risulterà elevato.
Nel caso di una forma acquisita di porfiria misure terapeutiche dovrebbe essere finalizzato al trattamento della malattia di base. Ai pazienti con forme ereditarie vengono somministrate trasfusioni di globuli rossi conservati. Con metodo radicale Il trattamento è il trapianto di midollo osseo.
Durante un attacco acuto di porfiria, al paziente vengono somministrati glucosio ed ematina. Per prevenire l'emocromatosi si effettuano salassi fino a 300-500 ml una volta alla settimana fino a quando l'emoglobina non scende a 110-120 g/l o fino al raggiungimento della remissione.
Anemia emolitica autoimmune
Malattia caratterizzata da una maggiore distruzione dei globuli rossi da parte degli anticorpi diretti contro i loro antigeni di membrana o da parte dei linfociti ad essi sensibili. Può essere primario o secondario (sintomatico). Questi ultimi si verificano molte volte più spesso di quelli primari e accompagnano alcune altre malattie -
Sotto il nome di "anemia emolitica" si intende un gruppo di malattie del sangue caratterizzate da un accorciamento del ciclo di vita dei globuli rossi - eritrociti. Per molti anni la comunità medica ha discusso la questione della legalità dell’uso del termine “anemia” in relazione a malattie simili: Dopotutto, il livello di emoglobina in questi pazienti è normale. Tuttavia, questo nome è attualmente utilizzato nei classificatori delle malattie.
Tipi e cause dell'anemia emolitica
Esistono anemie emolitiche ereditarie e acquisite.
Anemia emolitica ereditaria
Il primo gruppo comprende l'anemia causata da anomalie geneticamente determinate: disturbi strutturali delle membrane degli eritrociti (membranopatia), diminuzione dell'attività degli enzimi importanti per la vitalità degli eritrociti (enzimopatie), disturbi nella struttura dell'emoglobina (emoglobinopatie).
Le anemie emolitiche ereditarie più comuni sono l'anemia falciforme, associata alla sintesi dell'emoglobina “errata”, che conferisce ai globuli rossi una forma a falce, e la talassemia, che si manifesta con un rallentamento dello sviluppo dell'emoglobina.
Anemia emolitica acquisita
Quali sostanze possono avere un effetto dannoso sui globuli rossi che causano l'emolisi? Ecco qui alcuni di loro:
- arsina (idrogeno di arsenico). Formato in condizioni produzione industriale E per via aerea entra nel corpo;
- fenilidrazina. Utilizzato nella produzione farmaceutica;
- toluene diammina. Questi composti possono essere avvelenati in una fabbrica per la produzione di coloranti e numerosi composti polimerici;
- cumene idroperossido (hyperiz). Utilizzato nella produzione di fibre di vetro, gomma, acetone, fenolo, poliestere e resine epossidiche.
L’anemia emolitica autoimmune si verifica quando il sangue materno e il sangue fetale sono incompatibili in base al gruppo e al fattore Rh (anemia emolitica dei neonati), nonché dopo trasfusione di sangue, in caso di fallimento della resistenza sistema immunitario ai propri globuli rossi, che inizia a percepire come antigeni.
Sintomi dell'anemia emolitica
L'anemia emolitica è un gruppo di malattie in cui la durata della vita dei globuli rossi è ridotta. Segno caratteristico di tutte le anemie emolitiche è l'ittero, cioè acquisizione di un colore giallastro da parte della pelle e delle mucose. Perché sta succedendo? Durante l'emolisi (distruzione dei globuli rossi) questi vengono rilasciati nel sangue grandi quantità bilirubina, che causa tale chiaro sintomo. Ed ecco gli altri segnali generali anemia emolitica:- un aumento delle dimensioni del fegato e della milza;
- aumento della bilirubina nel sangue;
- oscuramento delle feci e dell'urina (l'urina ha un caratteristico colore "carne");
- aumento della temperatura corporea, condizioni febbrili;
- brividi.
Tutte le anemie causate da avvelenamento chimico sono generalmente molto simili. Inizialmente si notano debolezza, nausea e possibili brividi. In questa fase, raramente qualcuno finisce in ospedale, a meno che non si tratti di un avvelenamento di massa. Poi tutti questi sintomi aumentano, inoltre compare dolore all'ipocondrio destro e alla bocca dello stomaco, febbre e urina viola. Nei giorni 2-3 compaiono ittero e insufficienza renale.
Talassemia
La talassemia, che è una grave malattia ereditaria, presenta sintomi molto specifici: cranio e ossa deformati, forma degli occhi stretti, sottosviluppo mentale e fisico, una tinta verdastra della pelle.
L'anemia emolitica del neonato "porta" al suo proprietario involontario sintomi come ascite (accumulo di liquido nella cavità addominale), edema, alti livelli di globuli rossi immaturi e un pianto acuto e sottile.
Diagnosi di anemia emolitica
La cosa principale nella diagnosi dell'anemia emolitica è il quadro ematico. Si osserva una diminuzione (moderata) dei globuli rossi e dell'emoglobina, microsferocitosi (diminuzione del diametro e ispessimento dei globuli rossi), reticolocitosi (comparsa di globuli rossi immaturi), diminuzione della resistenza osmotica dei globuli rossi e bilirubinemia. A Esame radiografico tratti di conduzione del midollo spinale (mielografia) si riscontra un aumento dell'emopoiesi. Un altro importante segno diagnostico- milza ingrossata.
Trattamento delle anemie emolitiche
L'anemia emolitica (soprattutto ereditaria) viene trattata efficacemente solo mediante splenectomia, ovvero la rimozione della milza. Altri metodi di trattamento apportano solo miglioramenti temporanei e non proteggono dalle ricadute della malattia. Si raccomanda l'intervento chirurgico durante il periodo di indebolimento della malattia. Sono possibili complicazioni dopo l'intervento chirurgico (trombosi sistema del portale), ma non sono obbligatori.
Anemia falciforme, talassemia
Per l'anemia emolitica (falciforme, talassemia), vengono utilizzate trasfusioni di globuli rossi e sostituti del sangue. È importante che il paziente non provochi una crisi emolitica trovandosi in condizioni favorevoli all'ipossia (aria rarefatta, scarsa quantità di ossigeno).
Anemia emolitica autoimmune
In trattamento anemia autoimmuneè importante determinare il fattore che porta a questa stessa autoimmunizzazione del corpo. Purtroppo questo è molto raramente possibile e quindi viene alla ribalta l’uso di farmaci che inibiscano la produzione di anticorpi e, di conseguenza, impediscano la distruzione dei globuli rossi. Questo è (idrocortisone, prednisolone, cortisone), ormone adrenocorticotropo, cioè quelle sostanze che sopprimono la produzione di anticorpi nella milza. E, naturalmente, la splenectomia, che viene eseguita se il trattamento conservativo è inefficace. Ma anche questo non sempre protegge dalle ricadute, quindi dopo Intervento chirurgico A volte devi usare farmaci ormonali.Anemia emolitica del neonato
Per quanto riguarda l'anemia emolitica del neonato, per prevenirla viene effettuato un attento monitoraggio della presenza di anticorpi nella madre. Tutte le donne incinte con fattore Rh negativo dovrebbe sottoporsi regolarmente agli esami del sangue. Se vengono rilevati anticorpi, la donna viene ricoverata in ospedale, dove le vengono somministrate immunoglobuline anti-Rhesus.